Decrittare l’indicibile, lo scollamento, il corpo del nome senza nome, lato oscuro racchiuso nella dismorfofobia che tocca l’immagine di un incubo, le ombre come cadenze di muri insaturi e sparsi, che si proiettano come fughe fisiche e metafisiche, le città-coscienze che frequentano il doppio precipitoso e umbratile come vortice e si mescolano nel tempo e nei tempi.
Così come il buio che invade l’aria come un trauma, una fragilità di orizzonte, una mente persa. Ciò che svolge il nuovo romanzo di Ilaria Palomba (1987), Disturbi di Luminosità[1], edito da Gaffi, con in appendice un racconto inedito di Anna Corsini su Franco Basaglia, è una galleria di frammenti ritmati.
Esistono i nomi che si fanno materia, come la protagonista che non si sottrae all’abuso e perde, comunque la sua identità, affrontando la violenza a cui «sarebbe potuta fuggire e invece è rimasta lì ad aspettare che tutto finisse, forse per capire fino a che punto un essere umano può spingersi ai danni dell’altro», poi Lui, salvatore che ama e che dona la propria disarmata vitalità e potenza, L’Oracolo che è lo psicoanalista-Caronte, che sembra quasi riportare alla mente l’Hitchcock di Spellbound (Io ti salverò), con una funzione rivelativa e accompagnatoria fino all’ultimità, e Narciso, che dissipa e sperpera la corporeità, non come dono commosso, ma come possesso, brama, consumazione.
E ancora la spietatezza incisa del suo alter ego, Lei, sopravvissuto e sopravviventeDoppelgänger, diventata carnefice tra i carnefici. E l’agone infinito contro l’abisso e i suoi mostri che chiamano e richiamano, per un attimo si sospendono, e poi ritornano:
«Uno specchio sbrecciato è un corpo senza corpo.Non parlarmi di anima, l’abbiamo mangiata, l’abbiamo deglutita come zucchero a velo. Ora seguimi, sul bordo del grattacielo di qualunqueluogo, le gambe penzoloni, a masticar menzogne, a masticar sussulti di ciglia spezzate dal vento, a deglutire i simulacri di noi stessi in un cannibalismo che non ha pari. Aprimi, come un cuore vivisezionato da Dio. prendi tutto quello che c’è in fondo al torace. Prendimi l’ombra e lasciami nell’evanescenza dell’ora, genuflessa miliardi di volte nel corpo. Alla vista del sangue persino la mania si trasforma in grido. Grido silenzioso levato da bocche che non dicono più. Stammi lontana, amica di sempre, dico a Lei, ti vedo riflessa nello specchio, gli occhi azzurri, una ciocca di capelli miei tra le mani. Le forbici sono cadute frantumando i pavimenti. Sotto i pavimenti la notte dormono i mostri. Li conosci, i mostri? Ecco, vieni, te li presento: i loro nomi sono Insonnia, Avidità e Paranoia. I mostri, amico mio, stanno aspettando che infili le dita nel fondo della terra. Stanno aspettando di sfilarti le dita come fossero collant».
E ancora:
«Cercavo di riempire i vuoti con i corpi, le sostanze, il cibo e il sangue. Cercavo di riempirli con Lei che era il mio opposto. Con Lei che sempre mi vinceva. Con Lei che decideva di me ogni atomo, ma niente. Sono lo straniero di Camus e morirò in una prigione per aver ucciso qualcuno di cui non so nulla. Dai miei dodici anni tutti mi abbandonano, tranne Lui, Lui non l’ha fatto. Lui non è fuggito. E allora fuggo io. Mi respira accanto, e io non respiro. Mi ama, e io non mi amo. Gli dico: Come posso sentirti se non so amarmi? Stavolta ti lascio, non sopporto il perdono. Addio amore, mi consegno al delirio, non salvarmi più».
Nei frammenti si consuma sia l’ombra (alcuni personaggi, le voci, i battiti) sia la calibrata feritoia di ogni epifania salvifica e persecutoria che avviene come confine, fuga, flusso rappreso:
«Sei quel che inventi di esser stato, dice Lei. Per cui ora cancella le mani, le corde, le paturnie, i polsi divelti. Dimentica gli occhi e i denti e il puzzo di putrido dei tuoi vent’anni. Dimentica le ossessioni del mattino. Dimentica le tende che si gonfiano di fluido viola stinto, la pancia del demone, l’occhio di Dio, le carezze del satiro, il matrimonio indicibile della luce con le tenebre. Dimentica ogni cosa e danza, danza sulle macerie del tempo. Testimoni ultime, tu e io, sulle sponde del nulla, la perfezione dell’ora, senza radici, senza pareti, solo rizomi a pori aperti nello spazio. Prendilo, Narciso, e fattici una stagione, dice Lei. È bello, ti fa star bene, canta da Dio, non farti scrupoli. La più alta forma d’amore è l’erotismo. Ma non sposarlo. Non sposarlo mai. Ti dimenticherà. Non puoi paragonarti al mondo perché sei una sopravvissuta, lo siamo entrambe, vittima e carnefice, bene e male, essenza ed esistenza, entrambe sulla linea di confine, rincorriamo i gatti nella bruma di un varco, spalancate al ricordo, eppure già altrove».
Il cammino nell’esistenza pone estremità assolute (tentativo di suicidio, assunzione di stupefacenti, sesso promiscuo, dipendenza affettiva, psicofarmaci), e il corpo diventa l’immenso teatro di una consegna al baratro e alla non destinazione, fino all’annullamento, alla fine, al limite cieco e alla soppressione.
Qui la letteratura non teme di immergersi nella più lucida introspezione, ponendo le mani nel fango e nel livore, nelle tenebre e nelle sue palpebre, nella brutale finitudine, nel viaggio nell’Ade più nascosto che è inconscio e croce, pulsione di morte, gioia disumana e disperata vitalità.
In questa dissociazione, in questa divisione di corpo e anima («Ero tutte le cose transeunte, immanentemente viva e morta, eternamente sospesa tra due mondi, mai dentro e mai fuori, ma a mezz’aria di un limbo psicotico»), esiste un grido oltre lo strappo, il corpo sottoterra, il rumore ottuso, ed è il segno, la cifra dell’uomo che non si spegne, la profondità delle ossa che è gioia e letizia estrema, l’estasi dickinsoniana, e il corpo, ancora una volta, della mente.
Che rappresenta la chiusura in una limbica sospensione e rarefazione ma anche il divenire in atto, il rapimento di ciò che muta, la luce che non ha nome ma ha il coraggio di presentarsi, oltre le sue distorsioni-voragini.
E poi le città. Bari, genesi e passaggio, il sole infinito e l’odore di salsedine del Salento, il paradiso e la sua perdita, Roma, Milano, la furia nebbiosa di Berlino che seduce e abbandona, la musica potente di ogni nota che afferra le pagine, la performance che è tela dell’essere, fino alla sdrucitura dal nulla.
Nella dinamica del flusso interiore, nella scintilla instabile, che richiama e risente con evidenza e prepotenza, le Memorie del sottosuolo di Dostoevskij che vivono del contrasto tra la negazione e la resurrezione, abiezione e fulcro vitale, la visione della luce del tempo ne Le onde di Virginia Woolf, il flusso inarrestabile e paradigmatico di Dedalus di Joyce, poi ancora Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey, fino a Ragazze interrotte» di Susanna Kaysen, Psicosi delle 4:48 di Sarah Kane e il battito dell’ultimità nei Diari di Sylvia Plath, Ilaria Palomba compone il suo flusso, e lambendo la coscienza scissa della protagonista, pone sulla scena tra vittima e carnefice «una dinamica di dipendenza e intercambiabilità. Perché spesso siamo noi a permettere che il male che ci viene fatto possa poi essere da noi riproposto su altri: se non s’interrompe questa catena si resta in una forma primitiva di affettività e si collude con il buio[2]»:
«Io temo la vita, è lì che si annida il dolore, l’umiliazione, l’odio, il senso di rivalsa, l’ingiustizia suprema, nella vita, nelle increspature del linguaggio, nelle intercapedini del taciuto, nell’urlo dei bambini della villa attigua, negli sguardi di disprezzo per chi viene dal mare, non nell’oblio, non nella morte, dove il dolore cessa e si prepara al passaggio».
L’identità violata, il processo di dis-integrazione della mente, il trauma come frattura tra coscienza spezzata e intersoggettività, gli ossimori relazionali, la mentalizzazione mancante e la patogenesi determinano una ferita, una frattura insanabile e variabile con la vita, con l’estremità e l’abisso, con la violenza e i suoi detriti, con il confine dell’umano e il dolore invisibile:
«Nessuno poteva guardarmi dentro e io ne avevo orrore. Lui non può guardare, per quanto possa amarmi Lui lì dentro non può entrare. Nessuno può. Solo io posso calarmici dentro, calarmici dentro, calarmici dentro. Non ti è consentito di guardare senza precipitare. Quando sei troppo dentro non vedi più il fuori. Ci sarebbe un modo per stare bene ma anche stare bene fa male, mi fa sentire vuota e priva di identità, mi fa sentire simile a tutti, mi fa sentire di non poter parlare che di fatti, ma i fatti sono ininfluenti, i fatti sono Maya, la creta che c’è dentro è Ātman».
Esiste un’armonia segreta, quasi impercettibile, in queste pagine. Sono crepe sottili che tolgono ogni ritiro della luce franata che cede all’oscurità, un tremore che oscilla nella salvezza e nella dannazione, come una vertebra di sogno. I coni d’ombra e i ricordi, le fughe intersecate nel buio. Ecco il filo invisibile di Dublino, uno squarcio di apocalisse, di partenza e crescita:
«Fuggo a Dublino. Dublino mi salva, o quanto meno consola. […] Ho scritto e mi sono sentita a casa, nonostante le alterazioni chimiche, e non ho temuto il freddo, ho scritto e mi sono figurata una perfetta esistenza dublinese piena di libri e un lavoro qualsiasi, ma in grado di tenermi in vita. Mi sono figurata in giornate di gelo dietro ai vetri gotici dalle lunghe tende bianche, dietro ai rami riflessi nei vetri, dietro a un mondo freddissimo di ville antiche e cattedrali. James Joyce e notti anfetaminiche allo Schneider, musica trance e approccio facile, uomini spagnoli e uomini irlandesi dai lunghi dreadlock rossi. E io sola, senza nessun contatto, ma a posto nella mia solitudine».
In questa lacerazione che sfiora ogni infinitesimo punto dell’abisso, dentro ogni frantumo di frammenti, nell’assenza, nello sconfinamento borderline, il cuore cerca altro che non sia colpevole specchio deformato, cedimento dell’anima o svenimento[3], morte o cenere (disturbi di luminosità, appunto), tempo che sbrana, per inseguire lo sciabordio della vita, ciò che irrora e corrisponde, l’amore unico e vitale che annuncia l’azzurro, nella linea finale che separa il cielo dal suolo.
[1] Palomba I., Disturbi di luminosità, Gaffi Editore, Roma 2018.
[2] Morosi S., «Disturbi di luminosità»: Ilaria Palomba e la lotta contro il buio della violenza, in “Corriere della Sera”, 27 giugno 2018.
[3] Borrasso F., Le emozioni che partono dal corpo. “Disturbi di luminosità” di Ilaria Palomba, (http://www.sulromanzo.it/blog/le-emozioni-che-partono-dal-corpo-disturbi-di-luminosita-di-ilaria-palomba), 3 luglio 2018.
Palomba I., Disturbi di luminosità, Gaffi Editore, Roma 2018, pp. 130, Euro 15.



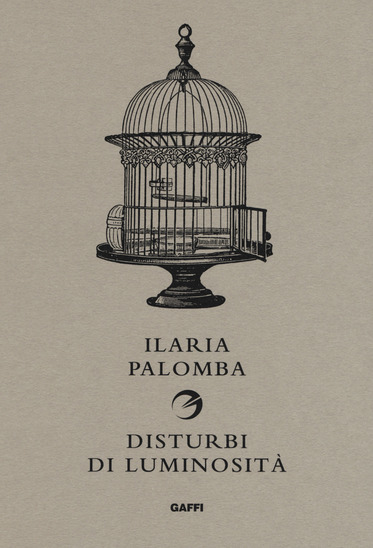
Pingback: Disturbi di luminosità Rassegna Stampa | ilariapalomba