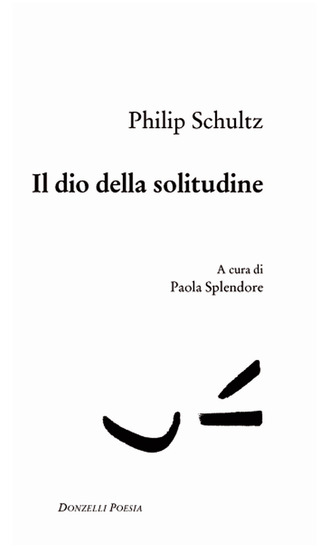Philip Schultz, nell’ultimo volume Il dio della solitudine[1], edito da Donzelli, lega un’erranza precaria allo stupore e alla sua dimora inabitabile e insulare: «Le mie poesie / saccheggiano quasi tutto, timori, progetti, / congetture e stupori, cercano prove / di infedeltà, frammenti di ispirazione. Indifferenti alla sofferenza che descrivono, odiano tutto quello / che amo, credono solo nella loro insularità».
La ricerca di ciò che è grazia per l’io, il racconto familiare il dialogo monologante radunano un’istanza primordiale e ordinaria[2], attraverso cui fare i conti e affermare il tremore dell’anima, come l’ebraismo che ne segna i contorni e lambisce i mari di ogni affetto o come il dettaglio che rammemora (Pumpernickel) una verità radiosa:
«Al di là di mille cortili la sua lapide / lo radica nella terra come un palo. Da solo, a letto, / sento il suo sangue che mi scorre nelle vene. / Da ragazzo passavo intere notti al luna park / a correre sul cilindro rotante della giostra verso la vetta magica, / dove credevo che mi sarei trovato al sicuro dal male, finalmente. / Come mi rompevo le ossa per liberarmene, / notte dopo notte, per tutta l’estate, io, ragazzo, mi arrampicavo / dall’altra parte del cielo, contro ogni scommessa, / come per essere tutt’uno con il tempo, / andavo sempre dove nessuno era mai stato prima, / le braccia mi sbattevano ai fianchi come ali».
Altrove, la figura materna, il mondo del dono, la luce immobile e impietrita, la pulsazione del tempo sotto la carne, che incolla ogni frammento di esistenza, certifica il sangue e la terra feconda di ricordo e abbraccio con il tempo di una ferita sempre aperta e di una stanza sempre vuota e nomade:
«Ricordo le lunghe passeggiate fino a casa, / le nostre mani un vincolo di così indistruttibile rivalsa, / ancora sento il sapore delle fresche cialde azzurre dei tuoi occhi. / Credimi, non c’era niente che non avrei dato, / niente che non avrei fatto per te. Ricordi il gioco che / facevamo quando mi afferravo alla tua gamba e tu dovevi trascinarmi / come una palla al piede per la nostra casa infelice? Nessuno di noi due / capiva che la stretta della consanguineità non è altro / che un abbraccio con il tempo. Madre, anche se non so liberarmi / di tutto questo dolore né far cantare la tua carne, e non so / ricambiare il dono così immenso, penso sempre: Questo / è per te, questa parola, questo respiro, questa fioca luce, / questa, la mia mano della pace, questa ferita sempre aperta».
Mentre il padre, «amato e detestato», rappresenta lo «specchio negativo del sogno americano, il padre del poeta si impegna in mille imprese fallimentari continuando a inseguire fino alla morte sogni di grandezza, ed è in nome del fallimento che Schultz gi innalza un monumento di grande forza[3]», come quando con lui vide l’America per la prima volta e tutto sembrava possibile:
«La mattina in cui il suo cuore si fermò mi feci prestare i soldi per seppellirlo / & i suoi occhi mi guardano ancora dagli specchi & lo sento ravvivare / la stufa con un calcio & sento il sale delle noccioline sulle sue mani / & i suoi consigli su come sollevare scatole pesanti mi aiutano coi libri che trascino di città in città / & ancora calcolo la distanza del tuono in battiti del cuore come mi ha insegnato lui & un giorno / ho guardato la grande rosa del sole aprirsi sull’oceano mentre fluttuavo sulla prua / del traghetto per Staten Island & avevo l’età di suo padre quando arrivò / con un vestito preso in prestito & una tale voglia di invenzioni & i ponti / erano montagne & i palazzi oro & il cielo si inarcava all’indietro / come una ballerina & i suoi capelli rossi carezzavano l’orizzonte / & i miei occhi bruciavano / in mille finestre & tutto l’Atlantico si frangeva ai miei piedi».
La poesia di Schultz è una lingua intorpidita dal viaggio che ritaglia e annoda sensazioni. Essere corpo, vetro nei polmoni che diventano suono, per aspettare che il seme dell’essere si trasformi in vita o in frammenti di giovinezza e di tempo, luce meno decisa, vista solo un po’ più scura.
Le braccia sono spalancate sulla figura e sul nome: «Le notti che ballavi il valzer nuda intorno al letto, / io abbracciato alla sedia che avevo ridipinto di azzurro, / i gatti che correvano tra le ali dei tuoi bei capelli biondi. / C’è molto che gli uomini non sanno delle donne, / come le tue mani trasformano l’aria in acqua, il seme in vita, / perché il sale sulla punta dei tuoi seni splende / & sa di mollusco».
Paola Splendore afferma:
«è spesso una data, un’ora del giorno, una stagione, a dare l’avvio alle poesie di Philip Schultz, o un oggetto, una strada, una persona. Elementi di per sé insignificanti, fortuiti, ma che accendono la memoria, annullano le distanze, squarciano i veli di rimozione in un abbraccio liberatorio con il tempo. Gran parte della lirica di Schultz sembra scaturire dal bisogno di assecondare ricordi che lo incalzano e lo assediano scagliandolo in un passato non riconciliato. Dettagli visivi, sensazioni tattili e il dolore ancora lacerante di affetti perduti si compongono alla fine in un insieme dove il passato è ancora vivo, e la lingua è sempre in un tumulto e fortemente emotiva. […] Schultz ripercorre nelle sue poesie momenti e passaggi nodali della sua esperienza biografica: l’infanzia emarginata a Rochester (NY), la precarietà esistenziale degli anni giovanili nel corso della guerra del Vietnam, il senso di stupore e quasi di colpa per il successo inaspettato, giunto in età matura, insieme agli affetti familiari […]».[4]
Laddove l’ironia e il senso del comico figurano un indizio di liberazione dalla paura (come le ali benedette del suo angelo custode Stein che citava Dante e con il quale egli imparava a memoria i rotoli del Mar Morto, chiedendosi perché le stelle appaiono solo di notte), la sua storia personale racconta di esilio e promessa, diaspora che consacra la bellezza sopravvissuta delle sillabe.
La luce intensa delle sue poesie racconta il tempo della scrittura, attraverso Yehuda Amichai e la sua immagine di soglie ombreggiate e distanze assonnate («Ricordo lo yogurt caldo del Mar Morto, / mentre agitavamo le dita dei piedi e tenevamo il sole in equilibrio / sul naso come foche ammaestrate, Dio per una volta muto»), Josif Brodskij («Continuo ancora a chiedermi / di cosa avranno parlato, il mondo come lo vediamo, o come vorremmo che fosse, / o qualcosa di più mistico, come la tristezza dell’esilio, / e il coraggio della primavera»), le mani mute sulla bicicletta di John Cheever («Ma niente contava, / neppure il dolore, lo conosceva bene, una forma di saggezza, / come i cieli che si spalancano alla luce, contavano solo / alberi, tempo e colline, mentre ci lasciavamo andare / a rotta di collo») e William Dickey.
Poi il Memoriale dei bambini e l’impossibilità di salvarli, la comprensione e l’amore di un frammento di silenzio e le anime vaganti di Harlem evocano l’onomatopea delle cose, le storie perdute, la vulnerabile bellezza dei volti come un lungo viaggio.
Il gesto fantasmatico di Philip Schultz recupera immagini perdute e dettagli sminuzzati della sua infanzia a Rochester, nel ghetto di Cuba Place quando si voleva colonizzare il cielo, senza speranza di redenzione, dove sua nonna saliva su una sedia per prendersela con Dio che le ha ucciso il suo unico marito, «la cui unica colpa era non ricordare / dove metteva le cose» e ricordava l’umiliazione e confusione del popolo ebraico.
Il bar mitzvah, le «displaced persons» negli olmi sconfitti, Mr. Schwartzman, a cui egli scrive lettere senza risposta, che guarda le pupille spente, le dita spezzate e le bocche colme di grida, impiccato a una corda di pianoforte nel suo stanzino, l’abbandono ai ricordi nell’ora arrugginita, Martin Buber e le storie ingoiate dalla terra.
Il passato è una estensione feconda e struggente che contempla il fantasma dei detriti, la promessa della vita felice, l’abbandono a una grazia da conquistare, ma anche la fitta di ciò che è andato, la dimidiata coscienza del popolo e le figure che abitano la scena del mondo, come l’uomo che piange il giorno del sessantunesimo compleanno: è la purezza del dolore, la santità del vero, la genuina umanità dei volti di sua moglie con le sue mani nel mare scuro.
Così disvela il dolore e la malinconia, dimora nella perpetua frattura della solitudine e nell’anima che invecchia fino a riempire la cantina di ciò che si fa fatica a portare dietro, assieme ai fantasmi:
«E mia moglie, c’è così tanto / che non le ho detto di recente, / di quanto veloce invecchia la mia anima, / una cantina che continuo a riempire / di tutto quello che sono stanco di portarmi dietro. / Potrei fare due passi con lei e cercare / di spiegare i fantasmi con cui parlo senza sosta. / O mettermi a leggere tutti quei libri accatastati / sull’inizio della fine della ragione… / Intanto, è così bello stamattina, / i colori che cambiano, la luce ipnotica. / Potrei sedermi accanto alla finestra a guardare l foglie, / che sembrano sapere esattamente come cadere / da un momento all’altro. O potrei lasciar perdere / tutto e ricominciare da capo».
La gioia proviene da una luce oscura che, pur invadendo i sipari, fa filtrare illuminazioni antiche, i ritorni e le catture, il popolo dell’estate abbandonata nel bui. L’orlo delle cose si annuncia inesorabile, sotto lo slancio solitario delle nuvole. L’illogica allegria di un tempo appartiene alla notte, «quando soltanto Dio veglia» o alla curiosa e splendente fragilità dei ragazzi «che rabbrividiscono nella luce gelida», come una promessa nella morsa del petto dell’oceano:
«Siamo venuti fin qui per la luce matura, / il silenzio del cielo immenso; per godere / dei timidi gioielli di vetro marino / levigato dalle maree del vento, / delle strida desolate e degli sghignazzi dei gabbiani / che vanno su e giù tra il loro mondo e il nostro. / Per stare in un posto rigoglioso, / solitario e un po’ nascosto. / Sull’orlo delle cose, / tra gli spruzzi scintillanti / e il puro luccichio delle conchiglie, / sotto lo slancio solitario delle nuvole / che trascinano i loro carichi misteriosi / avanti e indietro dall’orizzonte, / ciascuno un desiderio, un dono / che deve essere restituito»
Il fallimento è il limite indimenticabile e umano[5] dell’io verso il mondo, la sua angoscia e il rito della dimenticanza, ma, allo stesso tempo, l’emersione di ciò da cui non si riesce a fuggire: la figura del padre, vissuta con crudezza e verità (e la stessa ferinità dei luoghi che ne ricreassero l’immagine), i confini spostati e il disorientamento, il successo.
È il dio della solitudine, tremante nelle luci dell’alba, che vive nelle perdite riparate, nella base dei sogni e nelle mani nude:
«Questi uomini riparano perdite, gettano / le basi per i sogni degli altri uomini senza lamentarsi. Hanno aspettato al freddo fin dei tempi in cui Enea / fondò Roma su fiumi di sangue. Virgilio capiva che / la morte comincia e non ha mai fine; che è il dio della solitudine. […] Sembra che gli altri non sappiano cosa fare delle mani, / se le ficcano sotto le ascelle, o le lasciano cadere, / nude e inutili. È perché le nostre mani ricordano / quel che portavano, le promesse fatte? So / esattamente quando i miei figli avranno l’età per la guerra. / Presto tre di noi si metteranno in fila da Target, il negozio di fronte, / perché questo fanno gli uomini per i figli».
Se il presente tracima il futuro diafano ed elusivo attraverso una refrattaria tristezza che consuma ogni cosa, il sacrificio e il lusso della station wagon Pontiac del 1955, invece, rappresentano la perenne oscillazione della vita e della morte come luce opaca («Sedevo all’altro lato del mondo innevato, / e lentamente imparavo l’arte di / scomparire in qualcun altro») o come nella visita al Memoriale dell’11 settembre, «dove ciò che è necessario e ciò che atroce / si trovano a uno stallo impossibile, / dove tutto è già stato detto / e niente sembra essere mai esistito»
E poi, ancora, le preoccupazioni, vissute al Social Security Office o al supermercato, la Marcia delle Donne, la felicità e il sollievo come «la strana faccia porosa / del mio riflesso, / immerso nell’oscurità, / sua sola ricchezza», la ricerca di identità su Google e la sensazione amara ed austera di trovarsi in una palude infida di auto-analisi voyeuristica e di finzione compulsiva. Maschera in un guazzabuglio tra terra e cielo o ricerca di se stessi?.
La poesia crea la sua struttura quotidiana[6], partendo dal corso della vita che fluttua nella sitografia di ogni particolare lucente ed esplorazione esistenziale, come ciò che si nasconde, si afferra e si divora (si pensi alla moglie che scolpisce torte di porcellana).
Un’elegia per l’amico di Shultz, Robert Long, Welcome to the Springs, nella forma di una conversazione in un cimitero, nel loquace silenzio delle dune, porta alla rievocazione di un’indagine filosofica che ha origine dalla citazione di Baudelaire sulla lapide («La dispersione e centralizzazione dell’io. è tutto lì»), che porta alla domanda sull’ultimità dell’essere e alla ridefinizione delle illusioni nella parentesi estatica dell’arte:
«Ad ogni modo, è marzo, caldo e umido e ventoso, / è qui che vivo, qui, dove ogni cosa / vive nell’occhio e nell’orecchio, e una dolce frenesia / sommerge le lagune a testimonianza e lode, / dove i richiami d’amore del falco pescatore rimbalzano / tra il silenzio loquace delle dune / e l’onda lavante del chiaro di luna, / dove passano le anime dei morti dispersi, / formando e riformando ogni volta i loro contorni / in un’unica, luminosa, immaginazione perduta».
[1] Schultz P., Il dio della solitudine, a cura di Paola Splendore, Donzelli Editore, Roma 2018.
[2] Tillinghast R., From Comedy to simile, in “New York Times”, March 31, 1985.
[3] Splendore P., L’abbraccio con il tempo, in Schultz P., Il dio della solitudine, cit., p. 220.
[4] Splendore P., L’abbraccio con il tempo, in Schultz P., Il dio della solitudine, cit., p. 219.
[5] Vedi McKeon B., A success story rooted in failure (https://www.irishtimes.com/culture/a-success-story-rooted-in-failure-1.749520), “The Irish Times”, April 21, 2009.
[6] Blake Knowles L., The News from Poems, “Hudson Review”, (https://hudsonreview.com/2018/04/the-news-from-poems/#.W7Cq8PZoTIU), April 2018.
Schultz P., Il dio della solitudine, a cura di Paola Splendore, Donzelli Editore, Roma 2018, pp. 224, Euro 17.