Quella era una luce, ma
la luce a volte mente
per discolpare coloro che ama» lei mormorò
piangendo.
ADONIS
Leggere Ali Ahmad Sai‘id Esber, Adonis (vincitore di vari premi come il Nonino, il Goethe e il LericiPea per la poesia, più volte candidato al Nobel), nato a Qassabin, un villaggio siriano, nel 1930, laureato in filosofia a Damasco, poeta, scrittore, giornalista, che ora vive a Parigi, una delle menti più brillanti del mondo arabo, è canto puro di alvei migranti, un intreccio che sorveglia l’essere come la genesi carnale di ogni fibra e di ogni essenzialità conosciuta e consegnata al ricamo del mistero che si porge.
Per la casa editrice Guanda, è uscito La foresta dell’amore in noi, con la traduzione di Fawzi Al Delmi, che affida il breve tratto delle cose a una dinamica affettiva di splendore e pienezza («I nostri corpi sono il tempo e il luogo / ogni organo in noi è un paese e una storia / ogni palpito una festa»), ravvivata dall’interpretazione restituita del mondo e del suo rigoglio, di ogni passione stratificata e di ogni fertilità di vento.
In un’intervista rilasciata a Leonardo Martinelli, il poeta, parlando della propria origine poetica, racconta come divenne Adonis:
«[…] a 17 anni. Scrivevo poesie, ma non proprio classiche. Cambiavo già la metrica e soprattutto il ritmo, l’arrangiamento musicale delle unità metriche. Le inviavo a giornali siriani, ma nessuno le pubblicava. Un giorno, per caso, lessi del mito di Adone, divinità della bellezza e della caccia, amata da Astarte, diventata Afrodite e poi Venere. Un giorno Adone era andato a cacciare il cinghiale, ma alla fine il cinghiale, infuriato, lo aveva ucciso. Il suo sangue si trasformò in anemone, il rosso papavero. Ecco, diventai Adonis».
L’esilio dell’essere non è solo la spezzata frattura della genesi, è la fecondità che genera l’assenza, la migrazione sfrangiata che unisce l’universo all’apogeo della ferita e della bellezza («Solo questa lapide / è rosa eterna») che darà alla sua ombra il benvenuto, fino alla sfinita e rivoltata forma, che ricorda ciò che Borges scrive in Sabati: «Nel nostro amore c’è una pena / che assomiglia all’anima»: «La nostra ferita non è più una. / Ti ho incontrata – tu, la città – scritta dalle tempeste / col mare al suo apogeo. / Sono ancora il bambino invaghito della solitudine / il mio corpo, per lo stupore, l’esaltazione, / non sta più nella pelle. / La nostra ferita non è più una».
È il mistero che passa prima degli occhi, prima dell’incontro assetato di luoghi e di enigmi, di domande e eros imprendibile sulle scintille che zampillano:
«Il recinto si protende, la luna nuova / si flette sul suo arco / mentre il giardino / intessuto di piante, guarda: / da dove vieni o falce di luna? / Frastuono nella nostra galassia, lo senti? / Non ripetere, promettimi / di essere come eri quando ci incontrammo / tra le sue braccia – / di essere la seduzione, / il mistero – turbato e la domanda».
Adonis risveglia il campo muto della realtà con una sottile fragranza di cielo elementare, dove la propria primaria origine incontra l’ordine astenuto: «Il campo ha svegliato i suoi figli / il suo volto è coro, le mani / come chitarra. / Gli uccelli declamano le loro passioni / un usignolo immerge la sua afflizione, la sua corda / nel nettare degli alberi».
Esiste una satura sproporzione in ciò che si descrive. Una domanda annidata e una corda strappata sul limite: «Sotto un olivo, / si domanda sempre: qual è il mio male? / E dice ai rami: com’è salutare per me il mio male».
Ecco poi la notte, tracciata dalla ferita, poiché lo spegnimento di ogni luce trabocca nell’istante: «Traccia dell’accampamento dei suoi sogni. / La notte non aveva ancora spento la sua lanterna / quando, d’improvviso, / i passi del mattino lo condussero verso il sole. / Allora dove vai, cammino / tracciato dalle ferite».
La notte ridesta anche l’alfabeto dei giorni, esamina le distanze e pronuncia ondeggiamenti di orbite disobbedienti, la cui ira fanciullesca «fa rivivere sulla terra ciò che il cielo ha ucciso», per sorseggiare il nostro profondo:
«In tuo nome, in mio nome, noi ora ci addentriamo / nella nostra notte, / ne esaminiamo le distanze, / vediamo come si leva / e come cambia i suoi nomi e le sue regioni. / Eccoci ondeggiare / nell’alfabeto dei nostri giorni, / nelle sue passioni, / la mia voce e la tua si incatenano canzone dopo / canzone, / eccoci, sorseggiare il nostro profondo, / e recitare i suoi versetti: / non vogliamo altro che vagare nei nostri corpi, / non vogliamo altro che vagare nei nostri corpi, / non vogliamo altro che incamminarci nell’orbita / della disobbedienza».
La migrazione verso la nudità è una sillabazione di luce umbratile, un limite con dentro una trepidazione, una lettura di segreti che chiamano il nome indossato dell’amata e i suoi tratti: «Afflitto dalle ferite, dalla notte, circondato / dai miei dubbi, arreso alle mie scintille, / canto la mia migrazione in te, nella tua nudità, / nel mistero tra la mia libertà e te, / vivo nella gioia, lasciando me stesso / crocifisso sulle mie mura».
È il trepido esito di uno strazio posto in un ricetto di sogni e speranze, gettate alla soglia del cielo, al confine tra Oriente e Occidente, sul volto luminoso della terra e sulle trascrizioni del vento:
«Alberi sbadigliano e l’ombra ricopia / il loro itinerario. / L’ucciso (ricoperto) è incatenato / alla sua storia. Sussurra al volto luminoso della terra, / lo supplica: insegnami gli enigmi / come li hanno scritti i tuoi venti, fin dal principio, / per mescolarmi a questo spazio e restare tra le sue braccia come ombra, / senza tenerezza, senza ricordi, o canzone».
Ma Adonis smargina i confini, in cui la parola diventa sì il fulcro ma non la fine della realtà, il tempio conservato della lingua ma non la sua delimitazione.
È il suo sillabario ad abitare l’arazzo quotidiano, interpretando il gesto non in modo dogmatico e insuperabile, bensì vicino, connesso con la purezza di un prisma o di un tessuto stellare: «Abbraccio il tronco. La notte / e le stelle spostano le loro mandrie / nelle praterie. Il cielo rimpiange per il tronco / come me: un olivo, / frutto dei suoi fianchi, frutto del suo petto, / frutto dei suoi seni. / Abbraccio il tronco. Notte. / Tendo la mano alle sue passioni: / sogno nel quale vago / e che vaga nei miei occhi».
Roberto Galaverni scrive:
«Chi scrive poesia – certo se lo fa in un modo non meccanico e superficiale – è messo continuamente alla prova dalla non univocità del discorso poetico, a partire dalla consapevolezza del paradosso per cui la parola sarà tanto più autorevole (il che non significa autoritaria), tanto più persuasiva, efficace e memorabile, quanto più il poeta sarà stato capace di governare e armonizzare (il che non significa: eliminare) le diverse e contrastanti pressioni che l’hanno generata e che pure convivono in essa. Del resto, la metafora stessa, che della poesia costituisce il cuore, si determina appunto come relazione tra l’identità e la differenza. […] Ma che cos’altro è la poesia se non un processo di continua traduzione interna, un trapasso continuo di sostanze, caratteri, prerogative, nature, che diventa però visibile ed eloquente, determinando ogni volta quella che è la sua fisionomia specifica? Oriente e Occidente non sono soltanto un tema, ma la sostanza della stessa della poesia. Sono il suo cosa ma anche il suo come, un fatto di cui viene offerta testimonianza attraverso lo stesso corpo poetico. Di conseguenza, questo portico si dovrebbe ogni volta costruire e ricostruire tra i tanti Oriente e Occidente che si possono tracciare e pensare, a cominciare appunto da quelli che distinguono la nostra mente».
Nell’amore le cose mancate e vissute diventano il taglio di un’ascensione che interroga i nostri soprabiti e i nostri cenni di viaggio come sfera di metamorfosi e mistica senza Dio.
Tutta la bellezza e tutta la luce cosa sono? Cosa offrono nella loro fine purificata, nel loro Eden delle ginocchia?. Le cose sono nomi o singhiozzi?: «Che cosa staranno facendo ora le nostre cose? / Sono ancora là dov’erano? / Cosa sono questi bisbigli che indossano il vento? / Cos’è quella luce? Cos’è questa canzone? / È una confessione che si libera / nei meandri dei nostri giorni? / Sono i nomi delle nostre cose, / o i singhiozzi che precedono il denominare?».
Poi l’accenno ad un incontro, il nome di un ricordo che dà inchiostro all’esistere e un ritorno primigenio e puerile («Nel quaderno della terra io non sono altro che / una macchia che stilla in nome della strada / sui fogli della morte / l’inchiostro di questa esistenza»):
«Ti ricordi? Ci siamo incontrati per un’ora, poi separati. / Il sole era giallo come curcuma, / il vento soffocato. / Non ti ho sfiorato ma ho immaginato i tuoi seni, / i tuoi fianchi, le natiche, e quel che è sotto / l’ombelico astrale, / non per altro se non per l’idea di ritornare bambino / e restituire al mio volto i suoi lineamenti / e al mio tempo i suoi primi tormenti».
O ancora quando l’anima viene liberata dalle catene della notte, riconosciuta in uno spargimento dubbioso e sensuale: «Ieri, quando ci siamo incontrati, / liberavo la mia anima dalla notte delle sue catene, / insegnavo alle sue ciglia / come guardarti. / Guarda, eccola ora scorrere tra me e te / la chiameresti onda? / La chiameresti rosa? Prendila, / cospargila sulle tue labbra».
La lingua, che ama il suo fondo senza fondo, vive, allora, l’amore come una luce di continente che riporta noi a noi stessi, alla acqua delle maree, fino all’interrogazione del corpo nel luogo che diventa «tempo della tradizione delle nostre membra» e «il tempo come luogo?».
La foresta dell’amore in noi è una disgiunzione abitata, una coniugazione insediata nell’abisso, nell’impossibile che dà nuova immagine al mondo, perché «il cammino che porta a noi – / a scoprire la nostra ferita / e la sua cicatrice, / è sospeso»:
«È la lingua / che mi abita in tuo nome – ha fatto scorrere / il suo sangue in me in tuo nome – ha cantato / i nostri corpi e quel che c’è stato tra me e te. / Che cosa sono queste lettere sparse / dalla foresta dell’amore in noi? Qual è il tuo nome in / questo / istante? Venti, / a volte è un male, / a volte finge di esserlo. Che cosa, / siamo forse diventati lo stesso sangue? / La lingua ti avrà cambiato?».
A tal proposito, dice il poeta:
«Il corpo umano è un tutto e, se esiste uno spirito, questo è la pelle, il corpo, che è spirituale. E il corpo della donna è un continente: per capirlo, bisogna rivederlo ogni giorno. Non si fa mai l’amore due volte. Credo di avere espresso in La foresta dell’amore in noi questo concetto meglio che altrove. Una poesia carnale, che parte da un pensiero…».
E qual è allora il nostro luogo? Cosa dimora nelle nostre profondità astrali? Adonis non si muove nelle certezze. È una domanda inesausta e incredibile, una danza di orli, di alti boschi, di insicurezza vivente e mani di cenere. Ancora una volta il corpo trasudato e tracimato che entra nella profondità screziata dell’essere, per trasfigurare la materia e gettare un ponte tra la passione che divampa e l’argilla delle parole, e, infine, «viaggia / in una nube di terra»:
«Il luogo dal volto fatto di vuoto / e le mani di cenere / il luogo dove non c’è nulla / se non i suoi spettri / il luogo dove gli spettri parlano / delle loro tradizioni e desideri / il luogo che non è che polvere / nei venti del tempo / il luogo dove le sue lacrime sono cammini / e i tormenti patria / il luogo dove il suo sole è nato / schiavo. / Il luogo dove non c’è luogo. / Qual è il luogo che i nostri corpi hanno voluto? / Dov’è? Da dove? Come entrarvi? / Abbraccia il nostro patto, / trattienilo di sera, sommergilo, / chinati su di lui e chiedigli: / qual è il luogo che i nostri corpi hanno voluto?».
Nell’esigenza di annotare lo splendore dei corpi che si amano nel libro della polvere, Adonis percorre la stratificazione cosparsa dei ricordi, come una polvere sopita o immagine nuda nel miraggio del ricordo, mentre egli si ripara all’ombra della rosa e delle sue foglie, fino a cadere in balia.
Il corpo dell’amata si rinnova tra le labbra, come le sue cosce astrali, «due stretti, due altalene / i guanciali sono stormi di nuvole / che vanno / e vengono, / delirano / cercando un interprete».
In ogni suo dettaglio, tutto riluce e accade in un ritorno d’oblio e inchiostro, perché la verità e il sogno «sono due bambini: uno è lo spazio / l’altro il tempo»: «tra le mie mani e in ciò che vedo, scende / e risale in me. Un corpo uguale / al fuoco, all’acqua, al vento e all’alchimia».
Poi pone domande continue e le squaderna, lasciando l’evento al suo culmine e poi lo rintraccia nella memoria, nel tremore, nei sospiri, nel fuoco, nelle lingue, nelle navi, nelle carovane, nelle impronte di passione e nel desiderio verticale: «La sua voce – ricordo – una rauca ferita, / tremula, salta sopra il recinto, / e si insinua negli strati dell’aria. / Il cammino verso casa è fanciullo e vecchio / e veggente / il quarto è una rosa / che sillaba il cielo».
La dettagliata memoria si adagia sul tempo infinito e sulla fine, sullo sguardo insonne delle braccia («Il sonno è la terra delle sue gioie / il letto è la terra dei suoi tormenti»), sul fondo del suo diluvio, come il pianto, che cala specchi frantumati sotto le ciglia e sul corpo del presente: «Terrazze, finestre, olivo, / resti dispersi, / dov’è il tuo stelo, la tenera gemma / o rosa dei ricordi?».
Sono i passi che respirano le immagini, la luce disorientata che guida sulle mura demolite di casa, dove, ancora una volta i corpi, «foresta di boccioli», si uniscono al tempo, che come un profumo, «esce dalle loro corolle».
Il desiderio di amore è un mare aperto senza nostalgia di riva, o persino una casa aperta senza battenti mura o colori, dove perdersi in un antro che unisce, come la notte che cola leggera «tra le sue mani, indicandola» o la caduta rosa dei profeti, una stella che danza in segreto.
Essere onda e amare, strappati dalle tenebre e nati di nuovo, per imparare a illuminare l’eternità «dalle terrazze del suo nome» e disperdersi nel suo corpo, che «sa riassumere la terra / in una stanza / e unire il cielo a una sedia di paglia»: «Fammi tornare come voglio, / come ero, onde. / Ogni mia vena / è una nave d’amore, / non credere, / non ho mai detto / di avere nostalgia della riva».
ADONIS, La foresta dell’amore in noi, traduzione di Fawzi Al Delmi, Guanda, Milano 2017, pp. 162, Euro 12,50.
https://poesiainrete.org/2017/06/28/ogni-volta-che-di-notte-adonis/



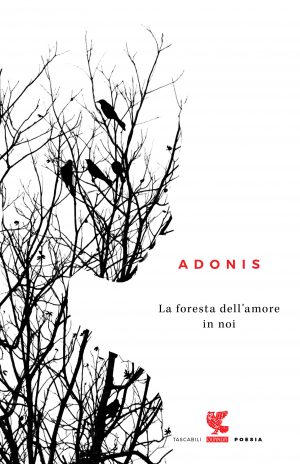
Pingback: «Dorme» – Adonis « Poesia in Rete