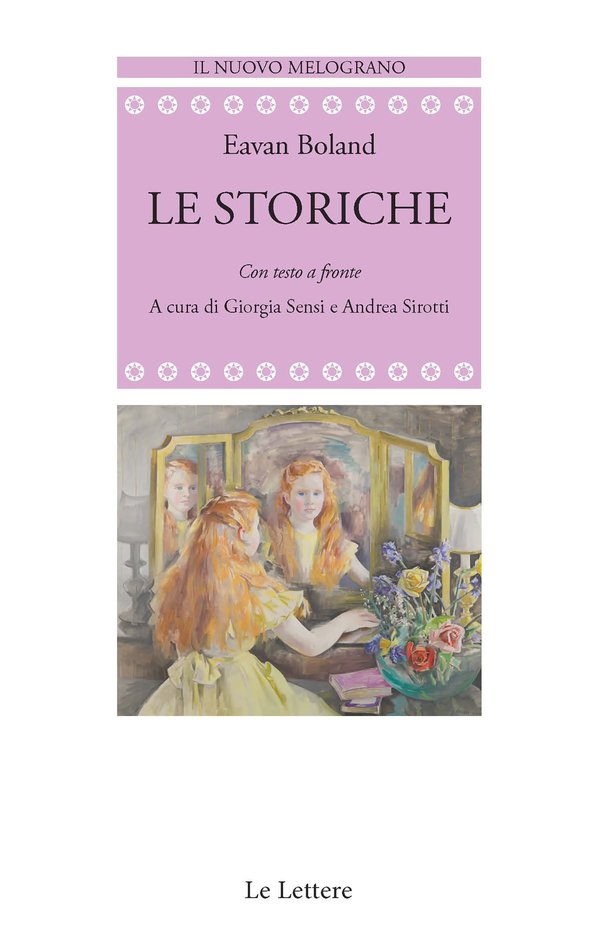Leggere Eavan Boland (1944-2020) è un’esperienza di racchiusa tensione. Il grande dolore per la sua morte, per l’Irlanda e per i territori anglofoni, la bellezza per l’ordinario e il dono dell’evocazione del paesaggio come segno dell’anima, come ha affermato il Presidente irlandese Michael D. Higgins, hanno portato alla riscoperta italiana della sua opera, grazie alla curatela e alla traduzione di Giorgia Sensi e Andrea Sirotti, con Le Storiche[1], edito dalla fiorentina Le Lettere, a distanza di alcuni anni dal bellissimo Tempo e violenza.
Se è vero che nei suoi quasi sessant’anni di scrittura, Eavan Boland, ha intrecciato mito, storia e affetti, come scrivono i curatori nella prefazione, è pur vero che la sua poesia è una voce intessuta e legata allo scavo, l’emigrazione, l’esilio, l’ordinaria bellezza dell’essere.
Il dettaglio è ciò che vibra, laddove la rappresentazione particolare dell’umanità è una parola dura e difficile, che lascia indietro il dono delle ombre, il vuoto delle nebbie, gli angoli remoti, lo sfratto umbratile della storia, come il morso del vento:
«Hanno le mani piene di parole. / Una di loro tiene il diario di tuo padre con l’appunto / scritto il giorno della tua nascita. / L ’altra ha i miei scarabocchi in rima, le mie ferventi lettere. / Prima che la poesia finisca / avranno briciato tutto. / Ora ripeti la parola. Evoca / la nostra isola: una storia che si doveva raccontare – / i patrioti che sanguinavano ancora nelle litografie / quando siamo nati. Chi ha scritto quel racconto / ha faticato per farlo suo. / Ma queste donne le abbiamo amate. / Archiviste con un compito diverso. / Impedire al ricordo di diventare storia. / Impedire alle parole di curare ciò che non va curato. / Fa freddo. La luce se ne va. / Ora s’inginocchiano dietro le loro serre, / sotto uno qualunque dei loro alberi. / Le foglie cadono lente. / Entrambe mettono un fiammifero sulla carta. Poi / avvicinano le mani alla fiamma. / Sentono il primo morso del vento. / Decorano le pagine col fuoco. Io smetto di scrivere».
Ed ecco che la poesia diventa non già un tema, ma una contro-storia che tenga lacerazioni e memoria, splendore gratitudine. La sua poesia sembra mormorare, offrire e porgere uno spazio di territorio e di ricordo, come un barografo che segna la pressione atmosferica:
«Nel frattempo noi percorrevamo / le vecchie strade, / sotto olmi morenti. Poi / venne un altro momento: i nostri schermi / si riempirono di cene per funerali / che guardavamo in silenzio, / e ciascuno di noi pensava / che ciò che era cambiato / era cambiato per sempre. Eppure / ogni giorno l’inchiostro tracciava la pagina, / il pennino ancora pronto a essere / ciò che era sempre stato: / scriba del nostro clima irlandese, / che non sa di sofferenze, solo / di ore che cominciavano, finivano, / cominciavano. Incapace di capire gli eventi, / solo il tempo atmosferico / in cui succedevano».
Ciò che è cancellato, vituperato e dimenticato riacquista una potenza nuova (si pensi alle sedici donne nel testo commissionato dalla Royal Irish Academy per celebrare il centenario dell’esercizio di voto alle donne irlandesi nel 1918), una forza che si ammanta di grazia, ironia, margine di splendore, luce perduta e voluttà, e queste poesie sono
«narrazioni intime, personali, dense di vivida carica evocativa, e hanno il pregio di collegarsi al futuro attraverso la memoria, la rabbia e la passione civile, contribuendo a riscrivere emotivamente, ma anche intellettualmente, la registrazione ufficiale di eventi che siamo soliti chiamare Storia. La storia, secondo Boland, non deve rimanere cristallizzata e fissata in una lapide o un monumento; i suoi protagonisti non sono eroi le cui effigi vanno conservate nei musei o le loro statue nei parchi pubblici. La storia è fatta di singoli gesti quotidiani. Di umile manovalanza e anonima dedizione a una causa. L’inconfondibile voce poetica di Boland rende universale l’esistenza individuale, celebrandone la fatica ma anche l’austera bellezza».[2]
In La doratrice del fuoco, il richiamo alla madre, la pittrice F.J. Kelly, unisce macro e microcosmo della storia e della quotidianità, dove la femminilità, il tempo fertile della donna, si amplia, diventando un fulcro di bellezza e cura. Il fondo alchemico, i passaggi di luce, le raffigurazioni di memoria e conoscenza impongono uno sguardo sul materno che sfronda ogni definibilità. Il limite della finitudine è un avamposto di visione e avvenimento:
«Amava l’argento, amava l’oro, / mia madre. Parlava dell’influenza / dei metalli, della congruenza degli atomi, / delle lezioni d’arte dove imparava / queste cose: pensa / diceva mentre mi raccontava che / per dorare una superficie un mastro artigiano / doveva fondere l’oro col mercurio, / doveva scaldarli entrambi per renderne uno volatile, / l’altro no / e per farlo bene / doveva separarli e poi / bruciare, bruciare, bruciare il mercurio / finché non scappava e lasciava / una pellicina di luce. L’unica cosa, aggiungeva – / ma cosa fosse quella l’ho dimenticato. / Ciò che lei passò una vita a dimenticare / potrebbe essere il mio argomento: / le cittadine cintate di Leinster, / i paesini costieri dove la lingua / del mare era tramandata, / le espressioni contuse dalle tempeste dei naufragi. Ma non lo è. / Il mio argomento è il ruolo che il desiderio ha / nel modo in cui i paesini vengono fatti / svanire, nel modo in cui io ho imparato / a separare memoria da conoscenza, / per renderne una volatile, l’altra no / e come ho iniziato a scrivere, / bruciando la luce, / costruendo calore finché d’un tratto / io ero la doratrice del fuoco / pronta a fissare radiosità, / pronta a decorare un è successo / con un non è mai successo quando / d’un tratto mi torna in mente / ciò che lei diceva: l’unica cosa è / che è estremamente pericoloso».
La malattia, che interrompe la giovinezza e disturba la terra, non tralascia la donna viva, la sua lucidità nel decifrare il presente e l’anima del passato, l’inquietudine ubertosa, la pioggia che sembra un dialetto e unisce il crepuscolo alle vie («Ho sempre saputo / che la pioggia era un dialetto che potevo ascoltare / nelle notti d’inverno: le sue sibilanti. / Anche adesso, in questa sera umida, / guardo mentre il crepuscolo arriva / al vecchio cimitero sopra la via / principale del nostro paese e mi rallegro per / chiunque vi sia sepolto che questa / naturale compagna non li ha / abbandonati, e mai lo farà»), la trasfigurazione visibile dell’anima attraverso le epoche, la continua nascita di sé stessi («È settembre. Le mele selvatiche sono sparse / sull’erba, le bucce lacerate dai becchi selvaggi. / È settembre. Ancora un’ora e sarò nata. / Fino ad allora non posso essere viva. / Fino ad allora non mi serve ricordare»), l’ascesa e la caduta, e, infine, la traduzione di ogni rappresentazione, come un dipinto da comporre.
Il suo margine è chiarità, si espone come le vocali graffiate tutto il pomeriggio con l’azzurrite. Un inizio di precisioni necessarie per trovare «la pienezza e la precisione necessarie / a portare le parole a casa, / alle colline d’inverno, alle stelle fosche di nebbia, / ai volti delle bambine che sfumano nel sonno».
[1] Boland E., Le Storiche, a cura di Giorgia Sensi e Andrea Sirotti, Le Lettere, Firenze 2022.
[2] Sensi G.- Sirotti A., Introduzione, in Boland E., cit., pp. 6-7.
Boland E., Le Storiche, a cura di Giorgia Sensi e Andrea Sirotti, Le Lettere, Firenze 2022, pp.124, Euro 18.