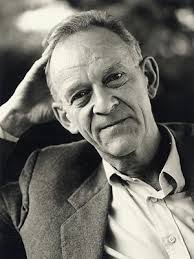Henrik Nordbrandt (1945) si impadronisce del seme dell’indefinibilità concentrica di ogni fiato che spasima, di ogni parola che diviene classica nelle forme «[…] talvolta estremamente concisa, stretta intorno al breve momento lirico, talvolta invece intrecciata in lunghi arabeschi, ma sempre basta su una lingua ricca e a tratti estrema nelle costruzioni sintattiche. E classica anche nei temi, che a un primo colpo d’occhio corrispondono a quelli della lirica centrale – l’amore, la morte, la natura – ma trattati con malinconia, sensualità, e soprattutto con la grande ironia con cui Nordbrandt sempre guarda il mondo e soprattutto se stesso» (Bruno Berni).
Danese, vincitore nel 2000 del Nordic Council literature prize, Norbrandt ha fatto confluire la sua gemma esperienziale nel proemio di una intonazione alta, che attraverso le sue digte (poesie), ha toccato le sottolineature della realtà con precisione ed essenzialità.
La sua fondamentalità rappresenta la prova di un’appartenenza autonoma, di una peculiarità che si sviluppa, non solo prescindendo dalle dialettiche poetiche a lui coeve, ma sorvolando lo spazio vergine della riflessione.
La sua linfa trae vita dai cieli di Turchia, Grecia e Spagna e in tutte le variazioni dell’Oriente mediterraneo, spingendosi nell’altura di una irrequietezza che è splendore e inquietudine («[…] ti voltasti verso di me / con il dito sul labbro / e le sopracciglia alzate / sorridendo, prima di continuare / camminando sulle punte / attraverso la stanza / illuminata dalla luna, abbandonata, / che d’improvviso compresi / avrebbe rappresentato la mia vita»), attesa e tensione, doloroso limite e sfarzo di grido («Tu sei il mio amore e la mia disperazione. / Tu sei la mia follia e la mia saggezza. / E sei tutti i luoghi in cui non sono stato / e che mi chiamano da tutti gli angoli del mondo. / Tu sei queste sei righe / cui devo limitarmi per non gridare»), sogno in disparte e incontro ([…] Ora posso in realtà solo guardarti / come si guarda un fiume / che ha trovato il suo letto / e lo assapora in ogni suo movimento / ogni sua ansa, ogni suo pesce / e ogni suo tramonto / fra i monti azzurri coperti di neve / che sono miei, e miei solo / perché fra loro ti sei aperta un varco»), come uno sconosciuto profumo che giace accartocciato: «Ho avuto questa rosa da una donna sconosciuta / mentre entravo in una città sconosciuta. / – E ora che sono stato nella città / ho dormito nei suoi letti, giocato a carte sotto i suoi cipressi, / mi sono ubriacato nelle sue taverne / e ho visto la donna andare e venire e venire e andare / non so più dove gettarla via. / Ovunque sono stato aleggia il suo profumo. / E ovunque non sono stato / i suoi petali vizzi giacciono accartocciati nella polvere».
Scrive Bruno Berni: «Ma il suo interesse per i paesi mediterranei non è quello di un turista, e ciò che lo ha spinto nel meridione d’Europa non è il tradizionale viaggio dell’uomo del Nord alla ricerca dei mondi esotici e idealizzati, bensì un sentimento di irrequietezza cui si è andata ad affrancare col tempo una riscoperta del tono casalingo e dei paesaggi danesi con una prospettiva più ampia. […] Nordbrandt ha fatto del viaggio una condizione di vita, con lo sguardo rivolto sempre verso un altrove, in un continuo alternarsi di partenze e di arrivi […] »
È nel senso dell’attesa che si compie la distanza di una memoria d’amore che irrora il mondo. Lo stesso dualismo tra qui e altrove diviene lontananza ancipite di istante e condizione, laddove la presunta inappartenenza afferma l’avvenimento come incontro e metafora di raggiungimento lucente che, come scrive Bruno Berni, tende «a illustrare e non a suggestionare»: «I giorni vanno in una direzione / i volti nell’altra: / Senza sosta si prestano luce. / Molti anni dopo è difficile / stabilire quali fossero giorni / e quali volti. / E la distanza fra le due cose / sembra più incolmabile / di giorno in giorno e di volto in volto. / È questo che vedo nel tuo volto / in questi chiari giorni alla fine di marzo». O ancora: «Del mare dell’estate c’è ora solo / il riflesso del tramonto, / del riflesso solo i volti / e dei volti solo l’attesa».
Saverio Simonelli commenta: «L’infinito, interminabile dissidio tra l’aspettativa dell’umano e l’apparente indifferenza di tempi e cose che li attraversano. Che vive di una tensione quieta, come in attesa di una scintilla che la animi e che scagli ciò che c’è dentro da qualche parte. Una sequela di termini astratti ma che paiono vitalissimi, adagiati nei versi ma carichi di energia e portatori di una fortissima richiesta di senso quanto più lineari, anodini, comuni. Concetti elementari tra i quali intercorre come un dialogo segreto, quasi fosse nel sottoscala delle parole. Come nei giorni e nei volti che «si prestano luce». Da dove viene questa luce? Luce che dà sostanza ma che può confondere, luce che forse si trasmette nel volto di una donna che si fa viva proprio in un giorno chiaro. È una poesia apparentemente algida eppure fremente, almeno quanto la sua domanda di luce, perché in fondo solo l’attesa non basta al cuore ed ogni tramonto inevitabilmente passa».
La domanda algida di Nordbrandt è «alone sui volti», bagliore-fiamma di città, amore che appartiene al solco dorato degli incontri, alla densità dell’istante in cui passato e futuro celebrano la loro unione spoglia, alla imprevedibile eleganza della visione come coscienza impossibile di prospettiva, attico di memorie e portale sacrale: «Il nostro amore è come Bisanzio / dev’essere stata / l’ultima sera. Dev’esserci stato / immagino / un alone sui volti / di chi affollava nelle vie / o sostava in piccoli gruppi / agli angoli delle strade e nelle piazze / e parlava a bassa voce / un alone che doveva ricordare / quello che ha il tuo volto / quando ne scosti i capelli / e mi guardi. / Immagino che non parlassero / molto, e di cose / piuttosto indifferenti, / che cercassero di a parlare / e si bloccassero / senza aver detto quanto volevano / e cercassero ancora / rinunciassero ancora / e si guardassero / e abbassassero gli occhi. / Le antichissime icone per esempio / hanno in sé quell’alone / come il bagliore di una città in fiamme / e l’alone che la morte imminente / trasmette alle foto dei morti precoci / nella memoria dei superstiti / Quando mi volto verso di te / nel letto, ho la sensazione / di entrare in una chiesa / distrutta dalle fiamme / molto tempo fa / in cui solo il buio negli occhi delle icone / è rimasto / piene delle fiamme che le hanno cancellate».
Ma questi amori superstiti ai detriti di sonno, alle palpebre come carovane di seta, alle notti stellate che si avvicinano, gettano ombre sui giorni inquieti e randagi e le mille strade percorse sono già andate verso il mare, sono già scivolate nelle nitidezze, mescolate agli aloni e alle dita che gocciolano per il miele: «E il tuo corpo, che è stanco di viaggiare / come una tribù nomade in estinzione / trasforma la mia anima nel mio sesso / mentre i miei pensieri diventano femminili / e fuggono, casti come polene / seguiti da una scia di sangue e profumo. / E il tuo profilo egizio si volta / verso il riflesso di un sapere obliato dei tuoi occhi nei miei / e fa accendere una serie di invisibili lettere che dicono / come tutto è già scritto, ma nulla è stato letto / finchè non sarà scritto ancora, dalla mia vita sulla tua e dalla tua alla mia / mentre uno di noi è sempre diretto da sud a nord / e l’altro sempre diretto da nord a sud».
La frammentazione, lo sguardo del suo discorso amoroso e naturale, l’approdo quasi assediato di mete, rivelano l’io lirico dinanzi alla maestà dei solchi affettivi e mistici: «Fra malinconiche partenze e disperati arrivi / senza conoscere la strada e senza compagnia / mi sono costruito una torre di crollate distanze / una cassa di risonanza di frammenti di vetro e profumi / in cui confondo me stesso con i miei infiniti inganni / e trascorro la notte desto e senza pace / spostandomi fra le stanze in cui ho distrutto la mia vita / e i mediocri sogni che vi ho sognato / circondato di bottiglie rotte, lamette ed estranee ferite / agenti di frontiera immortalati dai loro timbri / e donne cui la luna piena ha rapito il volto. / E adoro la distanza fra il mio distrutto io / e gli specchi che ho frantumato / i miei tatuaggi notturni e i miei lineamenti consunti / i fiumi illuminati dalla luna e le case vuote sui monti / e le caverne in cui mi sentivo a casa. / E mi vedo arrivare, ancora e poi ancora / per le ferrovie soppresse / su navi abbandonate dall’equipaggio / in isole incantate, emerse per la prima volta nel sole del mattino, / e in luridi porti che ho solo sognato / ma in cui gli ubriachi, le vecchie puttane e i piloti in pensione / mi riconoscono come colui che sempre parte» (Bichare, traduzione di Bruno Berni).
La profondità della restrittività, che solo nel prosieguo della sua scena diventa emersione vibrata, rappresenta la cifra di uno schianto di ombre e nostalgia di un accesso imperituro. Tutta la realtà gli ritorna in schegge fermentate e dimezzate e, come annota Dan Ringgard, «quando qualcosa accade con una forza così evidente, gli interrogativi sul senso e su Dio sono superflui. La realtà semplicemente esiste. Ed è un vuoto liberatorio»: «La tua presenza dimezza il mondo: / tutto ciò che tocco / tutto ciò che dilapido / ritorna in piccoli frammenti / come zucchero o schegge di vetro. / Ma io pretendo / una morte intera / camminare sopra la terra intera / e sentire la mia tomba soffiare / nei suoi alterni strumenti».
L’appropriazione, come un pugno di perle, è perdita che misura l’assenza, tenta l’incontro con una pienezza demarcata dove è possibile ogni invisibile sonaglio che il reale porta in vista, dove la calca della polvere sorprende ciò che si fermenta e dove l’ora presente sembra un transito famelico.
Esiste la dolcezza spietata dell’ora che passa, come un vestito sbiadito, ma che improvvisamente rivela la dimensione della memoria, come tattile emersione sbadata: «la dolcezza speziata del caffè amaro / mescolata al gusto della prima sigaretta del mattino / o l’odore di pesce e barche verniciate di fresco. / I vestiti sbiaditi sul filo fra i mandorli in fiore / o i monti che li mettono in risalto… / No, nulla di ciò, ma tutte queste cose insieme / rivelano che ho trascurato qualcosa / e che la sua presenza mi tormenterà per il resto della vita / perché l’ho ignorato mentre era qui».
Oppure il luogo diventa ricordo, sensazione umbratile e indizio di abbandono, presenza e fuga in un punto ispessito di se stessi che posiziona similitudini annerite: «Quando ci lasciamo, lasciamo contemporaneamente / tutti i luoghi in cui siamo stati insieme: / i sobborghi abbandonati con le case annerite dal fumo / dove abitammo un mese, città notturne / di cui abbiamo dimenticato i nomi, e fetidi alberghi asiatici / dove ogni tanto ci svegliavamo nell’afa di mezzodì / con la sensazione di aver dormito per mille e un anno» o ancora «Un posto dove i giardini notturni non ci portino / subito a vedere noi stessi / come fantasmi, dove la gente scorgendoci / non finisca subito per pensare / a chi è morto dopo il nostro ultimo incontro / e dove non compariamo nelle loro storie».
Avviene, pertanto, sempre un ritardo nel nostro periplo di sogni, nelle nostre fermate e ritorni, nel muro che rivela ombre indistinte e nelle luci oblique del sole. Tutto ciò non mette a tacere la vitale ricerca di ciò che compie: «Dovunque andiamo, arriviamo sempre tardi / a ciò che un tempo siamo partiti per trovare. / E in qualsiasi città ci fermiamo / sono le case cui è troppo tardi per tornare / i giardini in cui è troppo tardi per trascorrere una notte di luna / e le donne che è troppo tardi per amare / a tormentarci con la loro impalpabile presenza. / E qualsiasi strada ci sembri di conoscere / ci porta lontano dai giardini fioriti che cerchiamo / e che diffondono il loro pesante odore nel quartiere. / E a qualsiasi casa torniamo / arriviamo a notte troppo tarda per essere riconosciuti. / E qualsiasi fiume ci specchiamo / vediamo noi stessi solo dopo aver voltato le spalle».
È come se la realtà tornasse da una sperduta dimensione a celebrarsi. Ma è la poesia a far vibrare il suo tempio. Non ci sono altre vie secondarie. Essa è vita, sperdutezza e memoria spezzata, ma esiste e si afferma come discesa e splendore: «Diretti da Isparta fra i monti / ad Antalya sul mare / sediamo nell’autobus tenendoci per mano / e parliamo. Il sole / cade sulle cime innevate dei monti / scendendo. / Scendendo / dalle montagne al mare / con ogni probabilità nel mezzo delle nostre vita / ci parliamo / senza tacere nulla. Il sole della sera / cade su ogni singola / cima innevata dei monti». (Scendendo)
Commenta Bruno Berni: «Le figure centrali della poesia, il poeta e la sua donna – questa volta «colui che sempre parte» viaggia in compagnia – scendono dai monti verso il mare seduti nell’autobus e parlano. Il sole scende e illumina le cime innevate dei monti. Le due situazioni sono ancora sufficientemente isolate, il parallelismo non è ancora chiaro. Ma l’anadiplosi nel verso centrale, che i1 titolo sottolinea come un elemento fondamentale, funge da cerniera e mette in collegamento le due situazioni generali che si svolgono in parallelo con le due situazioni particolari, anch’esse parallele. Nella seconda parte della poesia il parallelo viene completato e l’analogia si chiarisce: i protagonisti toccano ogni argomento «senza tacere nulla», il sole illumina «ogni singola cima innevata dei monti».».
Il luogo diventa, pertanto, il territorio in cui accade la poesia e la materia vivente e dove lo specchio dei soggiorni testimonia, come scrive Dan Ringgard, a proposito della raccolta La Casa di Dio, «[…] una promessa. Ma il luogo cattura, come cattura la Casa di Dio. I ricordi diventano sempre di più e rendono pietre le parole, perciò prima o poi bisogna partire. La partenza è un’altra promessa. Tra la partenza e l’arrivo esistono tentativi falliti di fermarsi e calmarsi. La Casa di Dio è uno di quei tentativi, è un esperimento modernista con il vuoto e la pienezza, un lavoro per ridurre il mondo, scrivendo, al nulla e all’essere».
In un testo, Nordbrandt scrive: « «Ana ‘al haqq», dicono i sufi: «Io sono Dio». E questo / è per loro il massimo riconoscimento, / perché Dio creò il Mondo /come un mondo di specchi / nel quale ammirare la propria bellezza. / Quando lo vedo consegnare / una delle sue solite spiritosaggini / in forma di «News Week», / una vedova che fruga nei secchi della spazzatura / in cerca di qualcosa di commestibile / o un gattino / che i bambini di sei anni del paese / hanno abbandonato alla morte per inedia, / mi convinco che / Dio è un umorista, non un esteta. / E quando rido, la casa ride / dieci volte più forte / e continua a lungo dopo che ho smesso. / sei proprio una canaglia, Dio. / rimani quello che sei».
Paolo Febbraro commenta: «Protetto ed insidiato dalle pareti di una casa di campagna, e glorificato dalla fisica prepotenza del Mediterraneo orientale, il poeta ha scritto una splendida sequenza di componimenti che pian piano sostituiscono gli interrogativi sul vuoto del nome con la fatica rugosa del vivere. La frattura fra parola ed oggetto sembra ricucirsi grazie all’impietosa imponenza della realtà […], la natura di Dio viene sottratta alla speculazione filosofico-estetica del sublime. In fondo, Dio è solo ciò che accade con una naturale e indicibile forza, è ciò che non controlliamo e resta al centro di se stesso, al di qua delle nostre pretese contemplative».
Rimane il nostro accenno, la serietà dell’amore, la biografia disorientata, l’occhio sul peso della polvere, le rive opposte del tempo. Nella Casa di Dio dove c’è sempre vento, le lacrime vengono asciugate prima che siano visibili.