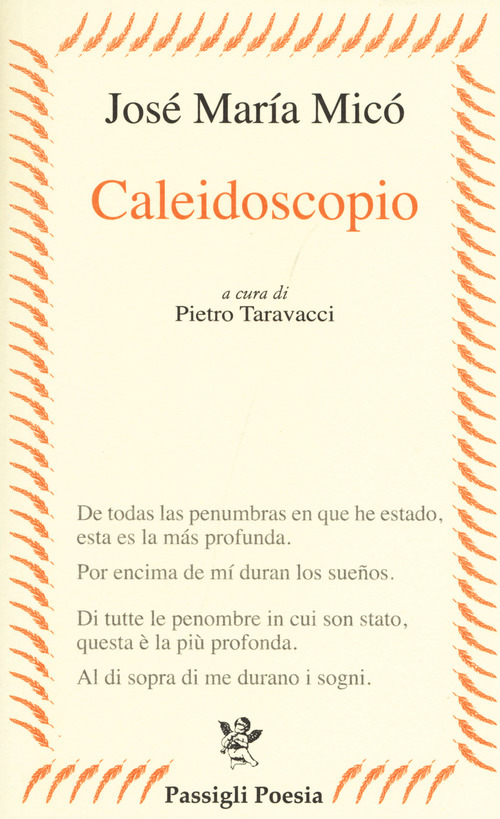Nell’avvicendamento fantasmagorico di colori, luci, ombre, immagini e figure, la poesia di Josè Maria Micó (1961), poeta e accademico di Barcellona, ma anche pregevole saggista, editore e traduttore, già insignito per la raccolta La espera (Premio Hiperión, 1992) e per la sua versione dell’Orlando Furioso, racchiude l’estro immaginale con il dialogo inconscio della memoria letteraria, con la genesi introiettiva dello sguardo, plasmandolo e arricchendolo di relazioni, esistenze e vitalità.
Nel volume Caleidoscopio[1] (pubblicato in Spagna nel 2013), appena edito da Passigli, grazie alla cura di Pietro Taravacci, la perfetta compenetrazione culturale che lega autobiografia e dato culturale
«non nasce da una percezione erudita o estetizzante della realtà, perché la sua prospettiva conoscitiva è, in sostanza, quella del soggetto nudo di fronte alla realtà che gli si svela nella reciproca assenza di un progetto e nell’imprevedibile esperienza della parola. Nella percezione del poeta c’è una toccante solitudine che chiede subito al lettore una qualche condivisione. E non potrebbe essere diversamente per un io lirico che da sempre segue un cammino così intimo, ma al tempo stesso così esposto, direi quasi senza riserve e senza limiti prospettici, agli elementi essenziali della natura, all’esperienza umana di ogni tempo, al quotidiano e all’avventura della parola».[2]
Il mondo di Micó contempla la variegata dicibilità dell’essere, il suo rapporto con l’insieme diversificato dell’alterità, la sua compresenza nel mondo, la «magica e prodigiosa trasmutazione[3]», l’allusività della realtà contingente, il dialogo resistente con il passato e l’abisso[4] aggrovigliato della sua inner vision. La precisa nudità del reale si svela in tutto il suo solco focale e taglio umido di specchi che si rifrangono, si distanziano, si associano in una galassia di immagini antitetiche:
«Il letto è uno specchio che ci lascia nudi. / La mia nudità è nera come bile di un cieco. / Cieco come il bambino senz’occhi che ha sparso / di queste viscere il bianco imprudente / con lo stesso retaggio di altri poveri / di greve e solenne mansuetudine. / Sono un mite cavallo cavalcato da tempi ciechi, e bianchi e denudati, / tempi per qualche vuoto gesto inutile / come questo umido taglio, perché il solco / è già aperto, / già è rotto il solco, / mio padre aprì la via, / e voglio dire il padre di mio padre, / che già di questa madre aprì le viscere, / e adesso è quell’uomo che nel letto ti copre, / povero giovine forzuto e vigoroso, / ignaro zappatore in questa grotta / splendente di lenzuola. / È adesso lui quell’uomo che ti copre, / ti copre e poi ti scopre come bimbo stupito / su un fosso senza fondo / innanzi a quella morte immersa che il mar liscia / ben oltre questo specchio».
Nello spazio del gesto poetico, il mirabile assolo della vita vissuta sembra toccare anche il territorio anonimo della spersonalizzazione e della precarietà. Nella contingenza della densità dell’istante, come vedere la propria donna, Marta, nuotare, si afferma un doppio movimento: da una parte il germoglio dell’istante raccontato, come una sorta di fenomenologia di ciò che accade, dall’altra la sua tensione alla vastità, alla rara finitezza degli infiniti e la lucidità indistinta delle cose, avvolte in una cara germinazione elementare di pienezza (La mia rosa senza un perché):
«Non ho fatto nient’altro in tutta questa estate. / Me ne sto qui al sole, graffiando l’orizzonte, / e la guardo che nuota, e intanto che l’oceano l’avvolge / nella sua onesta ampiezza, / l’aggirano i miei occhi riandando / dentro un sogno impalpabile e ardente / l’inabissata carne misteriosa / promessa di altre vite in quella stiva. / Guardo le sue impeccabili bracciate, / quella falsa indolenza con cui fluttua / al di sopra di tutto, / tenace e moderato / lo sforzo della spalla sorprendente, / la rara finitezza tra infiniti / di sabbia e aria e acqua, / un corpo che alla luce splende e fulge / sempre uguale a se stesso, / e frange flutti per unirsi al mondo, / lasciando dietro sé / un tributo di pelle per i pesci. / E il mulinare umano del suo impulso / rasserena la pace del mio sguardo. / Vedo / tutta questa pienezza nuova e vuota / nelle braccia di Marta, / che innanzi ai miei occhi nuota».
Maria Rosso commenta:
«La poesia è un’opera vivificatrice, che scaturisce in primo luogo dalla vista e illumina con la parola l’oscurità delle banali azioni quotidiane. L’io lirico contempla Marta che nuota, «rompiendo olas para unirse al mundo», e i ritmici gesti della donna appaiono come un rito cosmico, nel bagliore di una perfezione vitale, che si staglia sopra il nulla, ambiguamente evocato dalla polisemia del termine «nada» che chiude il componimento».[5]
L’esperienza fissa la profondità di ogni esperienza umana, ospitata in questi testi, facendo luce sulla presenza del tempo e della sua percepibilità fertile e nuova, della relazione tra l’estasi e la generativa illuminazione[6]. La domanda sull’essere ordina il suo senso, destinando le proprie viscere al fuoco che chiama il fuoco, fino alla rosa di carne del cuore «nata senza stelo».
La poesia testimonia, così, il suo lavoro dentro il tempo, la sua inafferrabile esposizione, la sua percezione fluida, la cronaca lieve di ciò che fragilmente si compone ed elegantemente si schiera:
«Vedo un bicchiere e tu lo vedi. Lo vediamo. / La mano mia, forse la tua, / lo riempirà d’acqua. / La mia bocca e la tua, a desiderare / la sua fresca pienezza, / lasceranno sul bordo il breve segno / di una soddisfazione non colmata. / Torneranno domani e sete e acqua. / Io spero d’esser qui anche domani. / Ti chiederò di nuovo se il bicchiere / esiste al di là di questa breve / favola di bagnata trasparenza».
Nel passo lento che spezza l’intimità dei principi, come avviene nel Giardino degli Agrumi, la ritmata profondità del tempo diventa dimora dello spirito, come se fosse una lunga tessitura di vita: «Ci si chiude il giardino come bocca / dubbiosa di una statua, / e lì, appena puliti dalla pioggia, / estranei alla rovina dei potenti / e ostili all’attacco della notte, / s’illuminando i frutti per lasciare / della loro bellezza l’acre dolce».
L’intimo dialogo con il passato raccoglie la figura del poeta catalano Ausias March, che nei Cants d’amor e inscena il sipario puro e infinito dell’esperienza relazionale ed affettiva. La luce e il dolore, l’oscurità e Dio, il movimento senza misura dell’essere attraverso un florilegio d’amore.
È, ancora una volta, lo scavo nell’anima tracciato nella terra che si nutre di desiderio e bellezza, non censura l’immondizia indomita che costeggia la nostra natura.
Pietro Taravacci commenta:
«In «Ausias March» il dialogo con il passato […] diventa senso di appartenenza alla poesia e condivisione di una ragione di vita. Ma l’intima interlocuzione con il grande poeta medievale catalano, priva di qualsiasi intento celebrativo e di qualunque culturalismo, suscita viscerali interrogativi esistenziali che sembrano trovare la chiave decisiva nella fulminea intuizione dei due poeti, che hanno colto (annullando ogni distanza storica), quei bimbetti (xiquets o chiquillos) che corrono nella piazza «segnati dalla lebbra della vita».».[7]
Se nella tasca dell’uomo si deve scegliere lo stretto necessario «e lì ci sta un poeta», come afferma Cortazar, citato in epigrafe nella sezione Materie (Materias), qui Micó compie una traiettoria essenziale («Sei la libertà / e sei il limite») ed albeggiata di isole che è piaga già esangue, collo di pietra, candela e fiamma («Terra per l’ombra delle ali in volo»). Spoglia la parola per entrarci, vede la materia nuda e assoluta, ritornando a una genesi primordiale, all’abisso lucente («Fondo che guardo come guarda un uomo / che vorrebbe cadere, e non si butta, / perché si specchia giù dentro l’abisso») e al mistero, come cifre indocili di un’esistenza unica.
È in questa lunga epigrafe insulare che nasce l’intima sostanza della poesia, il suo chiarore oltre-tempo, la natura melica (e quindi sonora) dell’arte che fa nudo il silenzio, deflora i prodigi e la mistica forma del distacco (Diego del Gastor), come il brivido di una minuscola notte che ritarda l’apparizione delle ombre (come l’omaggio ad Albinoni) e l’anadiplosi della sospensione effimera («Nudo e triste come un pozzo cieco», si legge in Tango amaro):
«Quando apro la porta e tu appari, / la luce è superflua, come il tempo. / Io so che tu domani / sarai solo un oggetto, / disteso come adesso, / rigido sotto il suolo, / ma intanto ora respiri / e sento il tuo ansimare. / La tua musica d’oro / fa nudo il mio silenzio. / Quando apro la porta e tu appari, / la luce è superflua, come il tempo. / Che voglia di restarmene / con nient’altro che un corpo / fatto di tristi briciole, / allegre nel tuo fuoco! / Se non ho più le forze, / il tuo mucchietto d’ossi / porta in spalle la carne / che ti aspetta nel letto. / Quando apro la porta e tu appari, / la luce è superflua, come il tempo» (Tango dolce).
Nell’oscillazione tra taedium vitaee pienezza involontaria, nell’accumulo dei desideri insopprimibili e insaziabili, l’amore prosaico spinge a una stimmung lontana e impalpabile che tende al compimento, la anela senza essere ricolma, ne scrive, come in una veglia, «fino a quando le cose andranno meglio. Per ora vanno male, continuano così: un lento e intenso fuoco, ostinato come la raschiatura o il bruciore di una vecchia caduta […]».
I testi di Momenti (Momentos), vissuti nella figura del viandante, abitano la svestita quotidianità e la precisione dell’orologio, colmano l’intera verità del limite del giorno nel mondo allegro e cisposo («E il mondo / indifferente al sole, al gas, al fuoco / tutto contorto delle caffettiere, / giù nella metro gli offre / un perverso riparo / di familiarità con quegli estranei») e il respiro della notte prima dell’alba, l’apparenza, la fine e la verità nascosta, consegnando:
«l’osservazione di una realtà frammentaria e occasionale di un «caminante» qualsiasi che deambula senza meta in un indeterminato spazio metropolitano. La voce poetica sceglie una modalità espressiva impersonale, di puro cronista, che registra con precisione scientifica quegli otto momenti, ma di fatto disegna, con eccezionale intensità lirica, un nuovo percorso del soggetto poetico, nelle vesti di un flâneur marcato a fuoco dalla desolata contemporaneità, da un tempo ormai defraudato di passato e di futuro».[8]
L’annunciazione del reale si frammenta in una fatale brevità di penombre («Di tutte le penombre in cui son stato, / questa è la più profonda. / Al di sopra di me durano i sogni»), di avvisi perentori, di contraddittorietà, lasciati allo svelamento della rivelazione poetica, perché scrivere è dare il nome al tempo dove «Ti aspetta un mondo / che è nuovo e tuo se giri questa pagina», e poi alle cose, alla gioia agli specchi.
Il caleidoscopio di Micó è un respiro immaginale che si concede alla memoria e al divenire, alla vita che si espone in un tumulto di simboli e cromatismi. Essi ricompongono lo spazio florido e frantumato dell’esistere e dei confini dell’oblio, per cercare il senso ultimo che svelandosi, arde, per essere purezza dissodata e amara di un approdo contrappuntato nel centro del sogno, e divenire Dasein di ciò che è altro e più puro:
«Che c’è dietro alla luce? / Altra, e più pura. / Anche il cristallo è aria. L’aria, nulla / che si possa toccare, né che pesi, / carica solo di un brillio che include / tutto quanto hai vissuto. / Niente che sia visibile. / Disegno senza tracce di una ombra / fatta di chiarità che ospitava / e ospita ancora / le persone che amasti, / quelle toccate senza amore un giorno / e i loro persi nomi che ora il vetro / ripete nei riflessi. E tutti hanno / la stessa forma, essendo stati uguali. / In quella loro massa, denudata / dell’essere e del vivere, dei tratti / che un giorno hai contemplato, / s’accalcano i loro abiti, e salive, / le loro urgenti frasi di speranza / e quei giorni di sangue di tua madre / quando non c’eri e lei non era nulla. / Adesso è tutto questo / un pozzo di colori, / un fumo incanalato che assopisce. / C’è altra luce al suo fondo, come nata / dal vapore di una vampa, che oggi è solo vapore, / rara tonalità di altra purezza, / un’incisione in più, dietro al tutto. / Pure il cristallo è aria, e nell’aria / vedrai, tutto infranto, / quell’ultimo colore, che ti incendia».
[1] Micó J. M.., Caleidoscopio, a cura di Pietro Taravacci, Passigli, Bagno a Ripoli (Fi) 2018.
[2] Taravacci P., Prefazione, in Micó J. M.., Caleidoscopio, cit., pp. 6-7.
[3] Pozuelo Yvancos J.M., Teoría del lenguaje literario, Cátedra, Madrid 1988, p.233.
[4] Cfr. Rosso M., Caleidoscopio. Josè María Micó, in «Tintas», Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane, 4, 2014.
[5] Id., cit., p. 268.
[6] Túa Blesa, Caleidoscopio. José Maria Micó, (www.elcultural.com/revista/letras/Caleidoscopio/32800), 10/05/2013.
[7] Taravacci P., cit., p. 12.
[8] Id., cit. pp. 16-17.
Micó J. M.., Caleidoscopio, a cura di Pietro Taravacci, Passigli, Bagno a Ripoli (Fi) 2018, pp. 129, Euro 17,50.
Micó J. M.., Caleidoscopio, a cura di Pietro Taravacci, Passigli, Bagno a Ripoli (Fi) 2018.
Pozuelo Yvancos J.M., Teoría del lenguaje literario, Cátedra, Madrid 1988.
Rosso M., Caleidoscopio. Josè María Micó, in «Tintas», Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane, 4, 2014.