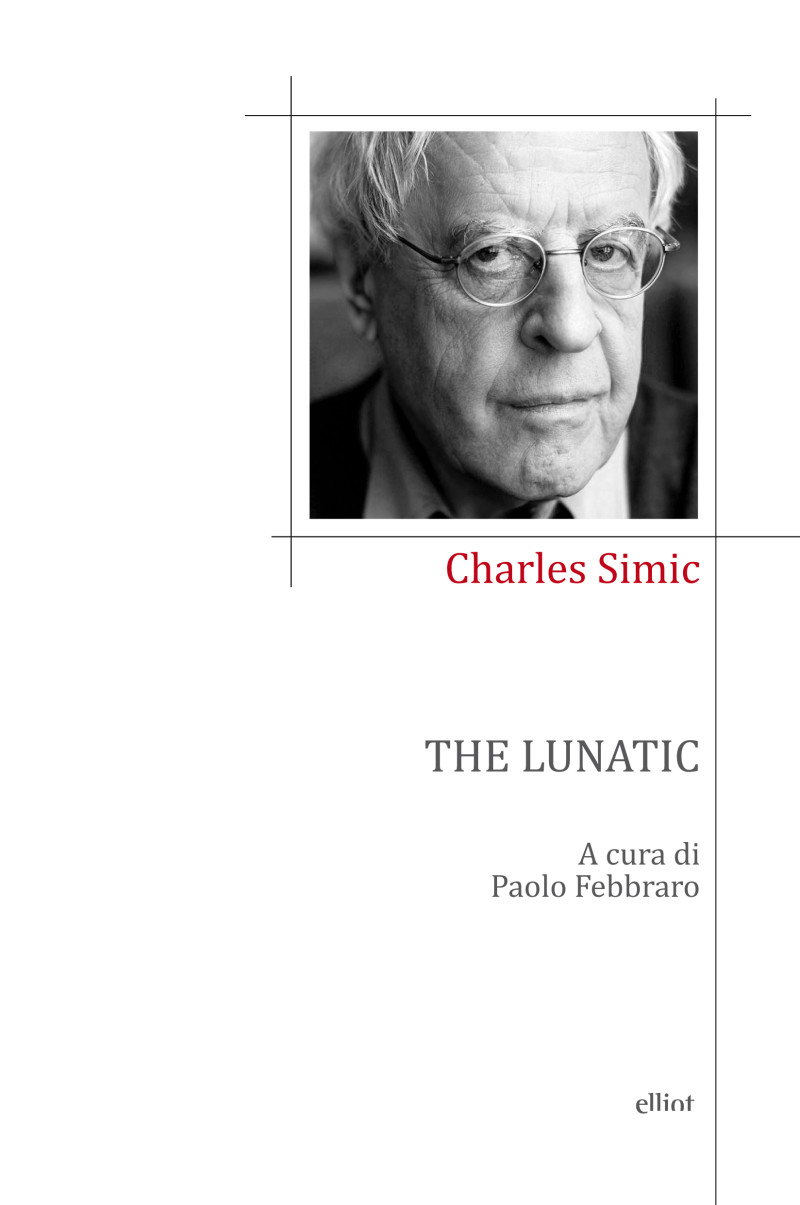La poesia di Charles Simic (1938), Poeta Laureato del Congresso degli Stati Uniti e Premio Pulitzer nel 1990, è una dattilografia insonne. La notte strofinata e fremente trema e porge il suo contatto e la sua inchiesta indicibile, fino al disarmo e alla lotta con i fantasmi che toccano le ferite. È la generatività di «un colpo agli assiomi della mente fotografica» (Irene Battaglini), in cui l’io trasuda ombre danzanti, con i sogni sul soffitto «imitando le foglie di un pomeriggio d’estate», sui muri che gocciolano:
«Sono il re senza corona degli insonni / che ancora sfida i suoi spettri con la spada, / studioso dei soffitti e delle porte chiuse / che scommette che due più due non sempre fa quattro. / Un vecchio bonaccione che suona la fisarmonica / mentre fa il turno di notte all’obitorio. / Una mosca fuggita dalla testa di un matto, / che si riposa su una parete vicino a quella testa. / Discendente di preti e fabbri del villaggio: / riluttante assistente di scena di due / rinomati e invisibili maestri illusionisti, / uno chiamato Dio, l’altro Diavolo, presumendo, è ovvio, / che io sia la persona che dico di essere» (Su me stesso).
Una estrema e arguta, dunque, a volte anche beffarda rastremazione e presentificazione dell’umano, in tutti i suoi gorghi e dettagliate normalità (ad esempio, Vi presento Eddie). Sono istantanee illuminate e frammenti di esistenze che riportano la cortina della bellezza vivente a disvelarsi e scoprirsi attraverso un fondo salpato, uno specchio sfaldato, eternità cicliche che si rivelano nei margini dischiusi dell’Atlantico tempestoso in un ricca tensione indecisa. Un margine ordinario che diviene piccola narrazione dell’istante che si mostra e si dischiude e, come afferma Phillip Lopate:
«Per quanto non strettamente incardinate metricamente, le poesie di Simic mostrano un notevole orecchio per i ritmici battiti di un verso, cosicchè persino quando il linguaggio sconfina nel prosastico non perdiamo mai la consapevolezza di star leggendo una poesia. Le sue strofe sono costruite saldamente, con versi all’incirca della stessa lunghezza e un flusso che mescola opportunamente punti fermi e enjambements».
The Lunatic, a cura di Paolo Febbraro, con la traduzione di Moira Egan e Damiano Abeni, edito da Elliot, legge l’umano in uno spazio minimo e intenso di ciò che germina e si consegna attraverso l’umorismo di una levigata superficie profonda: «Mister, abbiamo soltanto / una ciotola vuota e un cucchiaio / perché tu possa trangugiare / copiose sorsate di niente, / lasciando credere / che stia sorbendo una zuppa densa / e scura, fumante / della ciotola vuota» (Menu del giorno).
Scrive Massimo Raffaeli:
«Da tempo venute meno le cosiddette grandi narrazioni e, con esse, sia i sostegni sia gli alibi delle poetiche organiche, la poesia di oggi offre il meglio di sé nella rappresentazione di qualcosa che Mark Strand definì come l’eternità provvisoria dell’essere al mondo e cioè la messa a fuoco di occasioni della vita ordinaria, marginale, opaca e talvolta derelitta, ma capace di accendersi ed acquisire la pienezza di un senso, sia pure istantaneo e volatile. Se Strand dà voce alla sostanza più sottile del quotidiano, alle sue eclissi impercettibili e ai suoi trasalimenti emotivi, un poeta della medesima generazione e di pari rango, Charles Simic, sa coglierne invece i paradossi imprevisti, i momenti di sorpresa spiazzante, i frammenti di autentiche illuminazioni».
Charles Simic, dunque, conferma il suo dipinto di enigmi e quadri, in cui la cromatura dell’umano, sbattuto, ferito e splendente, miscela la grazia sopravvivente dello sguardo al wit esploso e lungimirante, la malinconia sospesa alla leggerezza umbratile di miraggio ed epifania: «Ne porta una nuova nidiata / nelle tasche del soprabito / quando vaga senza meta per strada, / e lascia un gattino qui e là / che corra libero come ammonimento / a me e a chiunque altro in vista; / indossa occhiali scuri, / sperando di non essere riconosciuto / quando entra da un fioraio a ordinare corone / per un paio dei prossimi funerali».
Il mondo attraversato, allora, non si comprime in un gelido e sopravveniente anelito lontano, bensì si sparpaglia in frammenti, frasi e fiati migranti, come afferma Roberto Galaverni:
«Disorientamento, incertezza dell’identità personale, perdita del senso, consapevolezza, anche per esperienza diretta, degli orrori della storia: tutto questo torna costantemente nei suoi versi. Eppure il suo discorso poetico non tocca mai il fondo. Nessuna insistenza, nessun compiacimento del negativo. Al contrario, leggerezza, sense of humour, autoironia, capacità di distacco, senso della misura e, insomma, quasi una specie di ultima grazia, costituiscono l’autentico marchio di fabbrica della sua poesia».
La scoperta di ciò che è umano è una conquista di accenno passante. Le immagini che si concretano sulla sua pagina incendiaria e breve assomigliano a una partita a scacchi con la realtà, divisa e unita dal buio e dalla luce. Assottigliare è creare la sintesi del mondo, dove la fioritura interrotta della scrittura si apre, spesso, al rilievo superstite, come gioia superstite:
«Quell’unica foglia superstite, che si muove appena / e che il vento non è riuscito a far cadere / per tutto l’inverno da un albero spoglio – / sono io! pensa il vecchietto / che portano a spasso sulla sedia a rotelle, / così che possa guardare i bambini / che giocano nel parco, le madri / che spettegolano dei vicini tutto il giorno, / mentre i piccioni che a turno atterrano / e decollano da un carro funebre appena arrivato e parcheggiato davanti alla parrocchia / gli trascinano lo sguardo qua e là» (Con comodo).
Paolo Febbraro, nell’introduzione, scrive:
«Simic è un poeta sentenzioso, aforistico, perché cerca i contenitori più adatti in cui porre delle entità fluide, camminatrici. Il suo artista è sicuramente Joseph Cornell, il delicato genio dell’assemblaggio e della giustapposizione di oggetti, collocati in scatole lavorate a lungo. […] Il nomadismo del colla giste raccoglie e collega oggetti sparsi e lontani, scommettendo sul fatto che il ridisporli nella propria percezione smentisca la falsa discontinuità dello spazio-tempo, e riveli invece il mistero dell’inconsapevole compresenza. Il gesto di trovare, avvicinare, montare pare a Simic il gesto creativo per eccellenza. In questo c’è forse il rischio di un fondo idealistico, la fede in una grande rete occulta del mondo, in una ferrea trama platonica, da illuminare per frustranti frammenti» (p. 10).
La gioiosa partitura della surrealtà, la figuralità oscillante come un barlume, l’ariosa finezza di ogni flusso compongono il suo lessico di malinconia e spostamento. La cartografia malinconica, che aduna confidenze di ombre, memoriale poroso e fantasmatico rimestamento di tempi, permane sì nel fondo segreto ma lo suggella attraverso i particolari rilucenti e precisi. Essi realizzano la comparsa di una fenomenologia possibile che si rende compatta, come sostiene ancora Febbraro, e così «sfugge a quella rete platonica e tentatrice perché è capace ogni volta di dare consistenza all’incontro fra Io e mondo, al loro coincidere in un convegno temporaneo che ci salva dalla dispersione mentre fa finta di celebrarla» (p.11).
È pulviscolo di un paradiso perduto che crea sempre un meraviglioso patchwork senza cesure, dove vedere permette di dare significato alla misteriosa congiunzione degli opposti e alla clandestina rinominazione del mondo: «[…] Splendido giorno, sei passato per il paese / come una sfilata di carnevale / con le donne dalle piume multicolori in testa / sui tuoi carri da parata, / lasciando alla luna in cielo / il ruolo di guardia notturna che con la sua lanterna / ispeziona ogni minima chiazza di neve / che ancora si nasconde nel bosco» (O primavera).
E creare sagome assottigliate è l’indizio della creatività lunatica, furtiva e penetrante, come se gli occhi isolati celebrassero ogni possibile vivacità dolorosa, ogni penombra interna, ogni tempo appartato che è duro lavoro quotidiano e ansia di eternità («La pioggia deforma il resto / sgocciando sul vetro / a cui ho appoggiato la fronte / come per calmarne la febbre»): «Lo stesso fiocco di neve / continuava a cadere dal cielo grigio / per tutto il pomeriggio, / cadeva e ricadeva / poi si ritirava su / da terra, / per cadere di nuovo, / ma ora in modo più furtivo, / con maggiore prudenza / mentre la notte si avvicinava / per vedere un po’ che succedeva» (Il lunatico).
A tal proposito, scrive ancora Galaverni:
«Da una parte l’origine, la radice, i ricordi d’infanzia, familiari, persino di tribù, e dall’altra il viaggio – Simic è un poeta del deambulare, con le gambe o con la mente che sia – nel nuovo mondo, scintillante, vario, imprevedibile, contraddittorio. E si può dire che la sua vicenda di uomo, così come nel tempo la stanno raccontando i suoi versi, non si trovi né dall’una né dall’altra parte. Non nella fedeltà alla provenienza, non nell’accettazione dell’approdo, dunque. Il luogo del poeta e della poesia è invece la terra di mezzo tra le due, un intervallo che coincide con la ricerca di una consistenza personale, di un destino sensato, con un tentativo ininterrotto di mediazione e di sovrapposizione delle due diverse figure».
La sua regia di silenzi e di parole escogitano accensioni continue e spietate. Descrivendo la meraviglia minima, egli pone la parola verso l’inseguimento di una gloria piccola e infinitesima che contiene altezze imponderabili e labirinti bianchi:
«Poiché ogni cosa scrive la propria storia / per quanto umile sia / il mondo è un gran librone / aperto a una pagina diversa / a seconda dell’ora del giorno, / su cui potrai leggere, se ti pare, / la storia di un raggio di sole / nel silenzio del pomeriggio, / di come ha trovato un bottone perso da tanto / sotto una sedia nell’angolo, / un minuscolo bottone nero cucito / sul retro di un abitino nero / che una volta lei ti chiese di riallacciare, / mentre continuavi a baciarle il collo e le allungavi le mani sul seno» (Storie).
Ed ecco che un negozio abbandonato, un barber shop, un bottone lontano o perduto («Morte chiede a una vecchia / il favore di cucirle un bottone, / e lei acconsente, scende / dal letto e comincia a cercare / ago e filo / con una candela che il prete / le aveva acceso sopra la testa») o un banco dei pegni testimoniano il primo accesso della luce della realtà, la sua continua revisione e illuminazione recondita. È il suo dizionario visitato e abitato da una pienezza ombreggiata:
«Forse là dentro c’è una parola, chissà dove, / che descrive il mondo stamattina, / una parola per come la prima luce / si diverte a scacciare il buio / dalle vetrine e dagli androni. / E un’altra parola per come indugia / su un paio di occhiali montati in metallo / che qualcuno ha lasciato cadere sul marciapiedi / ieri sera, barcollando poi via alla cieca, / borbottando tra sé o attaccando una canzone» (Il dizionario).
Attraverso il recupero delle immagini, l’autore descrive il suo orientamento cosmico (Robert Archambeau), fornendo una sorta di spazialità oggettuale e figurativa che tiene conto non solo dell’incidenza della storia ma anche del diapason della materia vivente, della permeabilità delle sovrapposizioni, dei mondi vitali e degli abissi che si incontrano, si vivono, diventando isolamento ambulante e scansione quotidiana di ciò che è animato, perturbante e incantesimo ossessivo: «Quando il vento del lago / ridesta i ricordi degli alberi / e le foglie scure si gonfiano / contro la luce che si spegne / in una copiosa effusione di tenerezza / – o invece è angoscia? / che ci ammutolisce tutti / attorno al tavolo da picnic, / e adesso non sappiamo se indugiare / sui nostri bicchieri o tornarcene a casa» (Sera di tarda estate).
O ancora in questo movimento effettuato con cautela: «Molto si potrebbe dire / di una mosca morta / sulla finestra / di una piccola baracca / e di una macchina da scrivere / di ferro che da anni / non solleva un martelletto, / che sia in deliquio / o in tetra disperazione» (Procediamo con cautela).
Il senso di abbandono e di mancanza o persino di angoscia di lontananze non procede misurando il tempo-fondo delle cose, sembra lambirlo per pronunciare l’elezione generativa di uno spazio unico e chiaro, in cui conquistare ogni possibilità umana o storica: «Ci sono un altro tipo di cielo, / una luce d’altro tipo / sui campi invernali, / un diverso tipo di buio / che ne segue le orme, / ansiosi di stare in nostra compagnia / in queste piccole case morse dal gelo, / che resistono coraggiose / senza neanche un cane in vista»(Una volta che arriva dicembre).
La nudità è una tensione solitaria di terno dove nella spoliazione dell’umano si insegue la luce e la sua definibilità anche in un recinto cimiteriale: «I nostri pensieri preferiscono il silenzio / in quest’alba senza uccelli, / al modo in cui la prima luce / cattura il mondo mentre lo svela / e non fa commenti / sulle mele che il vento / ha scosso da una pianta, / né sul cavallo fuggito / da un campo recintato che ora bruca / tranquillo tra le lapidi / in un piccolo cimitero di famiglia» (La luce).
L’ordinario insonne dei pensieri «che frullano sghembi come i pipistrelli / tra la vecchia chiesa e il cimitero» nella scoperta della musica notturna diventano, come scrive Paolo Febbraro, «traiettorie imprevedibili, pensieri-nottola mossi dal terrore per una immobilità cui non si riesce a credere, dal gioco vagante che serve a sfuggirle», perché, continua Febbraro,
«Simic coglie il mondo sul fatto, in flagranza (o fragranza) di reato, e il reato è costituito dalla bellezza e dalla trasformazione, dal modo in cui esse s’ingannano a vicenda. Di notte ogni cosa è liberata dal carico dei propri contorni, che si disfano o so sfrangiano. Vegliare, allora, è un atto filosofico, perché equivale a percepire il mondo dai suoi antipodi, a guardarlo mentre si spoglia della sua livrea, seducente e ridicola. Quando gli oggetti riemergono dal crepuscolo, quando pungono il nostro nervo ottico mantengono molta dell’energia nascostamente accumulata durante la notte: la ronzante energia della visione, vera promessa della sera che viene» (p.7).
Il suo esercizio di mutevole cambiamento di silenzio e irradiazione precisa addensa e infittisce l’espressione e i suoi orli, giustapponendo la potenza degli oggetti e delle visioni e dispiegando le loro correlazioni e i loro legami (Robert Archambeau), come l’esecuzione delle ore mancate nei fuochi morenti del tramonto:
«Forse sei uno dei tanti puntolini al tramonto / che vedo muoversi piano o restare immobili / a guardare il gabbiano in cielo o la chiatta / carica di spazzatura che passa sul fiume di sotto. / Il tipo di cui la sua famiglia non vuole più saperne, / diretto a una lezione serale di recitazione, che incrocia / in direzione opposta un anziano cameriere cinese / e un culturista e un’infermiera che si tengono per mano. / E che dire di quella in cui spero sempre di imbattermi, / anche se quasi non mi ricordo che aspetto aveva? / Potrebbe essere uno dei pochi puntolini che ancora indugiano / o quello che è sparito dall’ultima volta che ho guardato là» (Sul ponte di Brooklyn).
La sua evasione dai confini gli permette di mettere a fuoco il dettaglio emerso, la sua rappresentazione estranea e vicina, i relitti dei dettagli rimasti a metà, smozzati o naufraghi, l’orfanità memoriale del passato consunto che apre leggerezze inusuali e ritagliate nei giorni brevi e grigi dei quartieri derelitti come fiammiferi bagnati.
È nei suoi fermo-immagine attoniti e impensabili che la sua poesia sovverte ogni pronunciamento normale, il suo silenzio, il suo antro bisunto che , a volte, la realtà mette innanzi, per sovvertire i lampi di una percettibilità viva: «[…] La neve sputata dal cielo buio / rendeva insidiosi i marciapiedi, / nemmeno una persona in vista, / né un’auto a muoversi per strada. / L’immaginazione, vecchia attendente del Diavolo, / mi ha mostrato i suoi seni nudi / che si insaponava mentre passavo di fretta / perché il vento in faccia mordeva» (Vizi serali).
In questa polverizzazione storica e capillare di ciò che si presenta mancante, l’intreccio di Simic sostiene la sua ambientazione vegliata, celebrando penombre e aspettando che il nostro sussurro venga sentito «se non dagli angeli del paradiso / almeno dai dannati dell’inferno»:
«Qualcosa o qualcuno che non so dire / mi ha fatto sedere davanti a questo gioco / che dopo molti anni sto ancora giocando / senza mai impararne le regole né capire / chi vince o chi perde, / anche se mi spremo le meningi studiando / l’ombra che proietto alla parete / come uno che aspetta una telefonata / tutta la notte accanto a un telefono defunto / dicendo a se stesso che potrebbe ancora suonare. / Il silenzio attorno a me tanto profondo / che sento mischiare un mazzo di carte, / ma quando mi volto sorpreso, c’è solo / una falena contro la zanzariera, la sua mente / come la mia troppo agitata per dormire» (Telefono defunto).
Sono le sue scribacchiate al buio nelle notti oscure a rivelare non solo l’onirico tormento di un’attesa o l’ombroso teatro delle finestre, ma anche il consueto rumore dell’eternità nella veglia, la scontornata voce di passaggio nel mistero di una stanza vuota che celebra immagini dispari. L’osservazione e l’interazione tra le cose rappresentano l’essenzialità di gesti e sensi. È il dramma del mondo e la sua meditazione:
«Mi addolora vedere un’anziana signora agitarsi / contando qualche monetina davanti a un alimentari – / ma come la dimentico in fretta quando il mio dolore / mi ritrova – un amico sulla soglia della morte / e il ricordo della sera trascorsa insieme. / Provai così tanto amore nel mio cuore dopo / che sarei potuto correre nudo giù in strada / sicuro che chiunque incontrassi avrebbe compreso / la mia follia e il mio bisogno di raccontare / di come la vita sia crudele e insieme bella, / ma non l’ho fatto – nonostante le prove schiaccianti: / un corvo chino sulla carcassa di uno scoiattolo per strada, / i cespugli di lillà che fiorivano in un giardino, / e la vista di un cane libero dalla sua catena / che rovistava nella spazzatura di un vicino» (Così presto di mattina).
Simic si inoltra nel territorio inospitale e indicibile dell’anima, dove mancano le parole e il silenzio si fa più raggrumato: «Il mio argomento è l’anima, / di cui è difficile parlare / dato che è invisibile, / silenziosa e spesso assente. / Anche quando si fa vedere / negli occhi di un bambino / o di un cane randagio, / mi mancano le parole». È una coesione che cerca unioni inconsuete e, allo stesso tempo, tende fino al tempo, sfrangiandolo di albori e abissi:
«Queste nostre guerre con i loro orrori quotidiani / a cui pochi pensano e di cui pochi si curano, / mentre altri partono in silenzio per combatterle, / tornando ai loro amati in una bara. / Il buio precoce rende difficile / scacciare questi pensieri / o distrarsi con un libro, / ritrovare quel brano di Thoreau / in cui parla del sontuoso poema antico / detto inverno, che torna ogni anno / senza alcuna complicità da parte nostra, o forse / quell’altro in cui implora il cielo / di lasciarci vedere degli uccelli in giorni così, / dal piumaggio vivido, multicolore, che ci ricordino / la serenità e lo splendore dei giorni d’estate / tra gli alberi e i cespugli ghiacciati del giardino» (Uccelli d’inverno).
Simic C., The Lunatic, a cura di Paolo Febbraro, Elliot, Roma 2017, pp. 179, Euro 25.