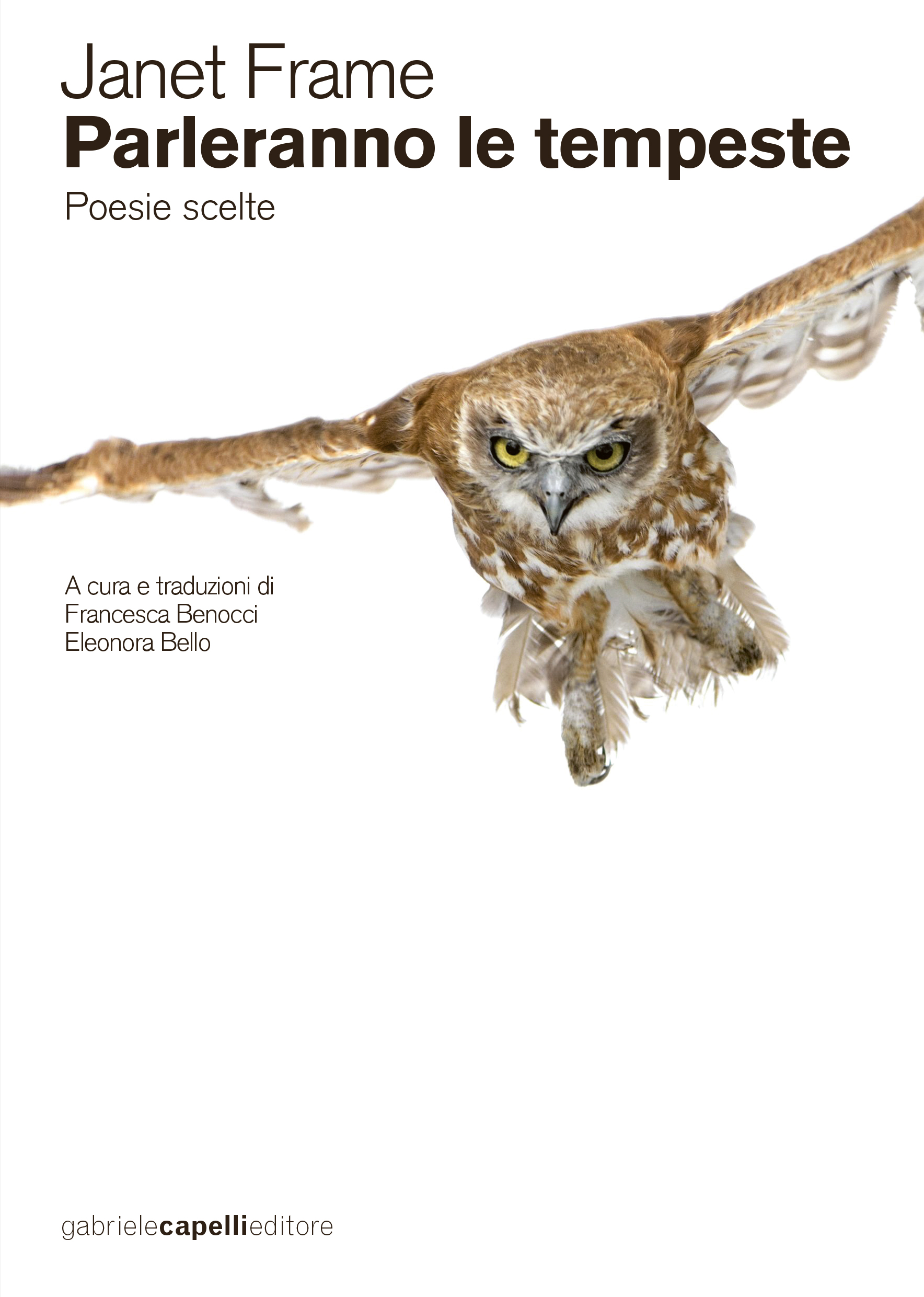Janet Frame[1] (1924-2004), una delle più note scrittrici neozelandesi, due volte candidata al Nobel, apparta la parola per farla sfolgorare, addensa l’orlo delle cose per sfiorare i contorni, rivelando le smagliature e le fioriture dell’essere, come ceselli di luce e ferita, pervadendo l’ombra e la vertigine come immersione e risoluto affioramento.
Grazie all’editore Gabriele Capelli e alla curatela e traduzione di Francesca Benocci ed Eleonora Bello, per la collana di poesia diretta da Fabiano Alborghetti, è stata pubblicata l’antologia, Parleranno le tempeste[2], con l’introduzione di Pamela Gordon (Janet Frame Literary Trust), che raccoglie cinquantatrè testi della scrittrice neozelandese, tratti da The Pocket Mirror (1967) e The Goose Bath, raccolta postuma del 2006 e ci restituisce, finalmente, una primordiale e remota bellezza.
Nata nel 1924 a Dunedin negli anni della Grande Depressione, in condizioni di estreme difficoltà economiche, sin da piccola, si rivelò brillante nei successi scolastici ma palesò anche un’estrema timidezza e una spiccata sensibilità.
Riuscì a diplomarsi come insegnante, ma poi successivamente, nel 1945, non fu considerata idonea all’insegnamento. Le venne fatta una diagnosi di schizofrenia e fu internata per otto anni in manicomio, e sottoposta a duecento trattamenti di elettroshock, rischiando la lobotomia, da cui si salvò grazie anche alla pubblicazione dei suoi romanzi e dei suoi racconti, tra cui La laguna e altre storie, Gridano i gufi, Volti nell’acqua.
Membro onorario nel 1986 della American of Arts and Letters, per la «potente indagine della coscienza umana e della sua collocazione nel mondo», nel 1993 ricevette, in Italia, anche il premio Brancati.
Nel 1990, Un angelo alla mia tavola, considerata una delle migliori autobiografie del ventesimo secolo, raccoglie tutti i segni vivi della sua cifra esistenziale, che è esplosione imprevedibile di immagine e curva abissale: dall’infanzia trascorsa a Dunedin, alla povertà degli anni della Depressione, dall’obesità infantile fino alla fatale morte della sorella Myrtle, e poi l’orrore dell’ospedale psichiatrico, la fuga, il tentativo di suicidio e la compagnia dei suoi poeti e scrittori amati, che saranno il suo eveniente splendore: Shakespeare, Shelley, Keats, Dylan Thomas, T.S. Eliot, W. A. Auden.
La regista Jane Campion decise di adattare per il grande schermo, la prima parte della sua storia, vincendo il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia.
La poesia di Janet Frame, che consta di centosettanta componimenti, sembra quasi nascondersi o appartarsi nelle pagine di narrativa, salvo poi rivelarsi come un’immagine imperitura, attraversando il confine e la sua ricerca disseminata, che disseziona «i più complessi sentimenti umani, il nascosto, il non detto» e «la sua capacità di trascendere colpa e vergogna nel resoconto delle passioni del mondo[3]», come segno e taglio.
Ed ecco che la scrittura diviene l’esatta contusione della propria illuminazione, la circostanza che incontra la sedimentazione violenta e caduca del nostro essere, l’impermanenza, la lacerata attestazione di ciglia.
Il dolore costella e attornia la nostra sfumatura di sole nel radicale tremore che ferma l’esser-ci («il penny cesellato della luce / che la nascita gli ha messo in mano»):
Le persone, scaldate fino alla fragilità / e immerse in acqua fredda, si spaccano. / Non sorriderò più. Latte, panni, spazzatura. / Persone gentili, sorrisi gentili. / Non c’è tempo per questo pasto lento del tardo pomeriggio. / Latte, panni, spazzatura. / Sì, sì grazie, non sorriderò più. / Sono venuta qui a scrivere storie e poesie, / non a preparare il croccante. / Arriva il buio, col sole ormai calato / su latte, panni, spazzatura. / Non sorriderò più. / Sono venuta qui per scrivere. / Severa, immersa, sana di mente, / rimesterò le sillabe / nella padella in dotazione; / dormirò sul materasso a molle, / girerò la chiave, / pagherò l’affitto, / stenderò protezioni di giornale, / spazzolerò la moquette da spazzolare, / ma sarò torva, niente sorrisi, mai più, mai più, / (latte, panni, spazzatura) / mentre scrivo le mie storie laggiù laggiù / nelle grotte di pietra del loro fondale. (Un proposito).
Centellinando la sua sporadica rivelazione, il gesto poetico risulta essere come il frammento più puro e versatile, lo specchio da tasca, appunto, che segna l’assolutezza dell’umano, in ogni svelamento e scoperta.
Includendo, come scrive, Pamela Gordon, nell’introduzione:
«la necessità di guadagnarsi da vivere, il che significava accondiscendere ai desideri dei suoi agenti ed editori producendo prosa, che era più vendibile. […] Frame evitava di farsi mettere sotto esame e riceveva controvoglia le adulazioni, il che la portò a considerare la pubblicazione postuma come parte della propria carriera, esattamente com’era stato anche per molti dei poeti che stimava, una fra tutti Emily Dickinson. Quando tentai di persuaderla a pubblicare il volume di poesie prima di morire, così che avrebbe potuto ricevere il dovuto riconoscimento, lei mi rispose “Non ho bisogno che nessuno mi dica che il mio lavoro è buono. Fallo dopo che sarà morta”. Bisognerebbe anche accennare che l’invidia maschile è una delle ragioni del tentativo di reprimere la vocazione di Frame per la poesia. […] La diffidenza della stessa Frame nei confronti della propria poesia è spesso citata come ragione primaria dell’autocensura, ma io credo si tratti di un’esagerazione. Come molti dei neozelandesi della sua generazione, era una persona schiva»[4].
È un respiro speso e sospeso che si appropria del suono dell’ansia ripida, del battito sporco e degli occhi caduchi e ciechi: «Provati estate primavera autunno inverno, / datemi il grande freddo per sempre, / ghiaccioli su tetti muri finestre il sogno / marmoreo perpetuo integrale di un mondo e di persone ghiacciati / nella più nera delle notti, così nera da non riuscire a distinguere / il sogno perpetuo integrale marmoreo. / Gli occhi ciechi sono ora padroni di sé» (Canto).
Niccolò Lucarelli scrive: «La sua poesia è avvolta in una triste bellezza che attraversa tutto lo spettro della composita realtà dell’esistenza umana: l’amore, la solitudine, l’ebbrezza, lo smarrimento, la fragilità, la curiosità, le ombre. Poesia dolce-amara fra luci e ombre, cieli ora azzurri ora tempestosi, specchio di tormentate vicende personali[5]»: «Il posto in cui le galline impanate / vanno a farsi le uova della colazione, / friggendosi al sole le creste color pancetta / non c’è più. / Sai quel posto — / nel cespuglio di biancospino / accanto all’albero d’acacia / accanto alla ferrovia./ Non mi ricordo queste cose, / — loro si ricordano di me, / non bambina o donna ma come loro ultimo pretesto / per restare, per non morire del tutto». (Il posto).
Laddove il frammento è l’istantanea che rammaglia e recupera la memoria, come apice in divenire, Frame avverte la sentenza primordiale della realtà e la sua manchevolezza, il paradigma del patire non come succedaneo ma come sua propria dorsale.
È un limite che fiorisce e si dipana attraverso l’inamovibile sentiero dell’appartenenza a un orizzonte franto e raso di memoria e volto. Dinanzi alla macerata realtà, c’è sempre un punto che riluce, inaspettato e rivelato, oltre il dolore, lo sguardo logorato, le parole accumulate e l’esproprio della propria natura:
«[…] Caro clown piangente caro vecchio uomo infantile / caro assassino gentile caro colpevole innocente / cara semplicità ti odio per avermi fatto credere / che esistano tanti mondi per una sola verità quando / lo so, lo so che non è vero. Cara gente come me e te / che abbiamo aliti cattivi, che non ci svegliamo in tempo e ci rodiamo / il fegato e ci controlliamo finché / arriviamo a casa nelle stanze vuote o con la famiglia, / cara famiglia, caro uomo solo nel logoro mondo di nessuno, / è per questo spreco che abbiamo accumulato parole per / milioni di anni dal primo sospiro, gemito, / e guardiamo le stelle. Oh oh non si può dormire sotto un cielo tanto vasto!».
I residui di Frame non si aggrovigliano nella rabbia. Essi sono l’ampolla vivida non soltanto di una separazione dislocata che nel silenzio si ammanta di luce amata («Poi oltre la porta era solo silenzio. / Le gazze ladre tappavano il buco della serratura / attraverso cui rassicuranti becchi di luce avevano pizzicato briciole. / Un inverno che non ho mai conosciuto / ha sigillato le crepe con un male chiamato neve. / Cadeva così pura / dal nulla, in fiocchi accecanti. / oltre la porta era solo silenzio. / Io indugiavo nel mio rituale solitario»), ma rappresentano il solco di un suono antico ed errante, che nel silenzio e nell’oscurità, riporta in superficie la discreta limpidezza, che diviene magistrale proprio perché sofferta:
«Mio nipote che dorme in un seminterrato / ha messo un pannello di ferro fuori dalla finestra / per catturare il suono della pioggia sul tetto. / Io non gli dico, Il cuore consola da solo le sue pene. / Un pannello di ferro ripara solo i tetti. Tuttora illeso dalla pretesa / che cambiamento e differenza non si vedano mai, può ancora / riparare i danni ricreando l’amato suono della pioggia / che crede di aver udito nell’infanzia. / Non gli dico nemmeno, Nella vita errante della sconfitta / il ferro è un fardello, che un giorno dovrà trovare / dentro di sé nell’oscurità totale e nel silenzio / quel ferro che non solo porterà il suono perduto della pioggia / ma anche il sole, le voci dei morti, e tutto quello che è passato». (Pioggia sul tetto).
La sua fermentazione poetica, dunque, sorbisce lentamente la sua visio interior, palesando come la quotidianità sia il vertice puro di ciò che accade, poiché si confronta con i detriti, l’imbrattato fulgore profondo, il cielo percepito e non visto più.
E nella piccola vastità di Dunedin, dove i dettagli sono l’ampiezza di una sostenuta ritrosia, il duro ossimoro, la parola tranciata di buio, la germinazione che aspetta di nascere sua nascita vivono nell’inaccessibilità di una stanza di parole abbandonate (I suicidi):
Mille e mille volte al minuto / la luce dei lampioni per strada si spegne. / Ho escogitato un metodo per poterlo mostrare / a coloro per cui i fatti della luce sono un mistero. / Prendendo questo specchietto, catturi il riflesso / della fila di lampioni. Tieni fermo lo specchio. Così. / Le vedi quelle strisce nere che si alternano al giallo? / Sono barre di effettiva oscurità ad occhio nudo impercettibili. / Per disingannare la vista uno strumento accessorio come lo specchio è necessario. / I sensi umani non dicono la verità se possono farla franca con / bugie credibili. / Tigri a caccia? Catrame spalmato di burro? / Il Signor Buio / in palandrana militare? / Un gatto nero su un letto di formaggio? / Piume di cardellino? Argilla e cipressi? Un panino di Paradiso / e Inferno? / Bruchi che avvolgono il tratto di strada / nutrendosi di oscurità per diventare farfalle la mattina? / Che posso dire, se non quanto questo carico di bugie ti opprima? / Farfugli di polline al sole, ginepraio dolce / di tulipani neri; mi ripeti che sai / quando sei chiaramente ignorante dei fatti della luce / e che volutamente tale resterai. / Aspetta! Ridammi il mio specchietto. Se si rompe / non avrò più chiara la vista e sette anni di sfortuna. (Lo specchietto da borsa).
Dinanzi alla parola, Janet Frame percepisce la nudità della corale recitazione delle cose, laddove il richiamo sensoriale si afferma nel presagio della destinazione. I particolari sono intimità scolpite nel bisogno, si segmentano nella vivente lesione dei margini e degli inciampi: «Dormire sognando una sicurezza / svegliando un’onestà; / il giorno privo di penombra / la notte di raggiri. / A casa e per strada / il pane caldo, la pietra fredda, / l’ardente, la gelida semplicità / d’amore e odio uniti, / frontiera in necessaria / se l’uomo non avesse memoria».
Il poeta, allora, «respira con un polmone solo / sale una scala con un solo piolo / spara alle stelle senza arma alla mano».
Nelle opposizioni dure e rastremate di luce e buio, di ricordo perduto e riaffiorato, gli effetti personali divengono il primario ritaglio infranto, l’amore indistruttibile e la chiarezza sbiadita:
«la qualità positiva intrinseca della luce, che s’insinua salvifica negli anfratti oscuri della paura, negli angoli bui della memoria, la luce che ci sfugge e talvolta persino deride, eppure che mai ci abbandona, nemmeno di notte, sopravvivendo in lucciole e lampioni; e il buio, la presenza minacciosa; non tanto sintomo di paura irrazionale, ma consapevolezza d’essere in qualche modo, in quanto esseri umani, destinati all’incomprensione e all’errore, alla trascuratezza e in ultimo, alla solitudine. Opposizione buio/luce che si lega intimamente al tema ricorrente della vista e della cecità. Il tutto è filtrato e amplificato dall’occhio “microscopico” dell’autrice, che ci conduce attraverso un’analisi chiara e illuminante delle contraddizioni umane e del senso della vita, lasciandoci con la netta sensazione, una volta lette le sue poesie, di sapere più su noi stessi di quanto non sapessimo prima».
Roberto Galaverni afferma:
«Contrariamente a quanto le vicissitudini della vita potrebbero forse far supporre (i tanti anni d’internamento in manicomio per schizofrenia, i continui trattamenti di elettroshock), queste poesie colpiscono per la chiarezza, il controllo, la precisione con cui riescono a definire questo o quell’aspetto dell’animo, della psiche, del comportamento umano […] Dunque non si tratta soltanto di conoscenza del mondo interiore, di cui la scrittrice sicuramente dà prova (come nei romanzi, del resto), ma della capacità di metterlo a fuoco con esattezza e piena responsabilità, con una padronanza talora sorprendente delle configurazioni metaforiche, che sono costantemente intese a chiarire, a definire, a illuminare, in sostanza, a mettere direttamente gli occhi o il dito sulla cosa, anziché a sfumarla, a prolungarla al di là di se stessa o a sfuggirla».[6]
E aggiunge: «Le immagini e le metafore della Frame nascono al modo di constatazioni. […] Lo scenario che più spesso ritorna, diciamo pure il principale termine di misura della realtà impiegato dalla Frame, è però quella di uno scontro costante, quotidiano, tra la luce e il buio, tra «il gradito consiglio della luce» e «la nuda / grotta della notte[7]».
The Goose Bath (La vasca delle oche) è segnato dall’esperienza della fine, della scomparsa, in cui anche il voltare delle pagine mescola infanzia e maturità, come una fiaba lieve di terra o una stanza (altra ricorrenza topica che ritorna come un’ossessionata labilità).
Il tempo, l’ascolto, le gocce pesanti, i diluvi sono voragini di relazioni profonde con la fragilità e la durata, la trasformazione e il velamento. Nello scorcio minimo e origliato, Janet Frame manifesta la sua lotta («Eppure ho sentito / di insetti stecco e sagome / e letti a righe / nel cielo e file / di fiori incorporei / in bianco e nero / miseri come gli arcobaleni contro la pressione / e la purezza / del non-colore. / Devo continuare a lottare / con la testa gialla e rossa / dal profondo della fossa, io rimanendo a modo mio») e la sua indocile invisibilità, che è pena dischiusa di rose come chiodi:
«Sono invisibile. / Sono sempre stata invisibile / come la povertà in un paese ricco, / come i ricchi nelle stanze riservate delle loro case piene di stanze, / come le pulci, i pidocchi, come un’escrescenza sottoterra, / i mondi oltre il cielo, il vento, il tempo, le idee — / l’elenco dell’invisibilità è infinito, / e, dicono, non fa buona poesia. / Come le decisioni. / Come l’altrove. / Come gli istituti lontani dalla strada di nome Scenic Drive. / Basta similitudini. Sono invisibile. / In un mondo di gente dalla vista binoculare, in fondo sono / in maggioranza / poiché io e te camminiamo con vista a mezzaluna nelle nostre / personali oscurità / attraverso un mondo in cui le decisioni di essere e non-essere / sono controllate dalla luce / aiutata dalle lacrime e dal sonno dell’incuria o dalla morte. / Sono invisibile. / Gli amanti mi trapassano la vita per toccarsi, / la pioggia che mi cade attraverso scorre come sangue sulla terra. / Sono trasmessa come sapere nella testa di nessuno. / Do libertà ai danzatori, / al dire la verità. / È così. Non c’è nessuno qui che origli od osservi, / e io imparo più di quanto mi sia concesso sapere.
La sua domanda elementare si dispone in aria di luce, in un amore che disassa il portello dell’oscurità liquida, dove il bulbo del buio freme nelle ferite del sole serbato («Niente può toccarmi, dice Luce / intima con il mio occhio. / Ed io ci credo, / ci devo credere. / Mi appello alla luce perché faccia un rumore universale / di trionfo in sé stessa / perché noi ascoltiamo e diciamo / Ecco finalmente è arrivato il gradito consiglio della luce»), portando dentro se stessa un viaggio di ceneri, una veglia di foglie e promesse. Parleranno le tempeste di sconfitta e la vita salperà come un’oscura marea.
Pensiamo a Punti dalle idee:
«Punti dalle idee ballavamo doloranti / finché Tempo non arrivò / con il forcipe usato per le Nascite / e ci estrasse il pungiglione dalla testa. / Potete dormire ora, disse, non temete altri sciami; / dimenticando che da un pero all’altro / le api invisibili devono andare / con borse di dolore come lettere d’amore / e odiose previsioni di neve / sotto il ridicolo farsesco sole / dove tutti urlano o cadono / in preghiera o morti / e l’unico film comico / è la vecchiaia che annebbia la vista / e uno sciame d’api senza tetto in testa».
Irene Battaglini si sofferma così sui versi:
«Se lo scenario del mondo di Janet Frame è il volo di un’ape, così la sua intera vita sembra essere vissuta come un battito d’ali che non tende a concludersi, che resta come un sospiro asintotico, sospeso tra inferi ed estasi, senza poter mai riposare in un limbo di possibili ripensamenti, di rimpianti, di rielaborazioni. Quel che contraddistingue lo scenario poetico di Janet Frame non è tanto la paventata schizofrenia, che non sembra ottundere il suo desiderio di meraviglia, né compromettere il suo anelito di affetti e meno ancora offuscare la sua qualità poetica che tende ad assolutizzare il lemma nella sua adesione iper-metaforizzante, quanto la schizoidia della sua percezione del mondo, che non può essere definito sulla scorta di un rapporto buono tra le relazioni oggettuali e le istanze intrapsichiche, quanto invece da uno stile di pensiero che vuole dirimere il seno buono da quello meno buono, senza potervisi soffermare ad assaporarne la dolcezza, attraversato da una epistemofilia delegata tutta alla parola. La logica binaria della ragione diventa a questo punto separante, e così il mondo delle immagini evocate dalla parola–logos si oppone a quello delle emozioni, segnando uno iato che somiglia ad una vagina carsica scotomizzante, in cui il pericolo è inciampare rischiando di non poter far ritorno al Sé. Per questo l’ape diventa cuore di un organismo più vasto, lo sciame, e nello stesso tempo organello individuativo. Perché soltanto una genialità poetica così spiccata poteva tentare l’impossibile, fare della schizoidia un segno di devozione al sacro ordine della Coniunctio Oppositorum».[8]
La sua linea è il suo compasso: una pienezza che deve comporre e assaporare ogni distanza, vivere le tinture di luce e il vento affilato in punta d’oceano.
Così le parole passano sul significato del cielo, scambiando i sogni con il mondo remoto. In questo scarto di mondo avviene la distillata purezza di ciò che vive e il motivo per cui la scrittura sorge da un’impronta di nome: «Vocali girano come ruote: il cocchio è vuoto. / Alte consonanti ardenti illuminano la strada deserta. / Scartando il mondo, / scartando il mondo / dove pini ancora dicono sola, sospiro, serata, e rifiuto, / rifiuto, e i loro aghi di inganno mi cadono negli occhi, / ho cominciato a scrivere».
Frame J., Parleranno le tempeste. Poesie scelte, a cura e traduzioni di Francesca Benocci e Eleonora Bello, introduzione di Pamela Gordon, Gabriele Capelli Editore, Mendrisio 2017, pp. 96, Euro 18.
[1] Per una ricognizione dell’opera narrativa di Janet Frame si vedano i seguenti testi pubblicati da Neri Pozza: Un angelo alla mia tavola, Milano 2010; Gridano i gufi, Milano 2011; Verso un’altra estate, Milano 2012; Volti nell’acqua, Milano 2013.
[2] Frame J., Parleranno le tempeste. Poesie scelte, a cura e traduzioni di Francesca Benocci e Eleonora Bello, introduzione di Pamela Gordon, Gabriele Capelli Editore, Mendrisio 2017.
[3] Benocci F. – Bello E., Nota delle traduttrici, in Frame J., cit., p.17.
[4] Gordon P., Introduzione, in Frame J., Parleranno le tempeste, cit., pp. 12-13.
[5] Lucarelli N., Janet Frame, poetessa delle contraddizioni umane, in «Leggere tutti», n.117, dicembre 2017.
[6] Galaverni R., Scontro tra luce e buio al tempo dell’elettroshock, in “Corriere della Sera – La Lettura”, 7 gennaio 2018.
[7] Id., cit.
[8] Battaglini I., Lezioni alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato, a.a. 2017-2018.