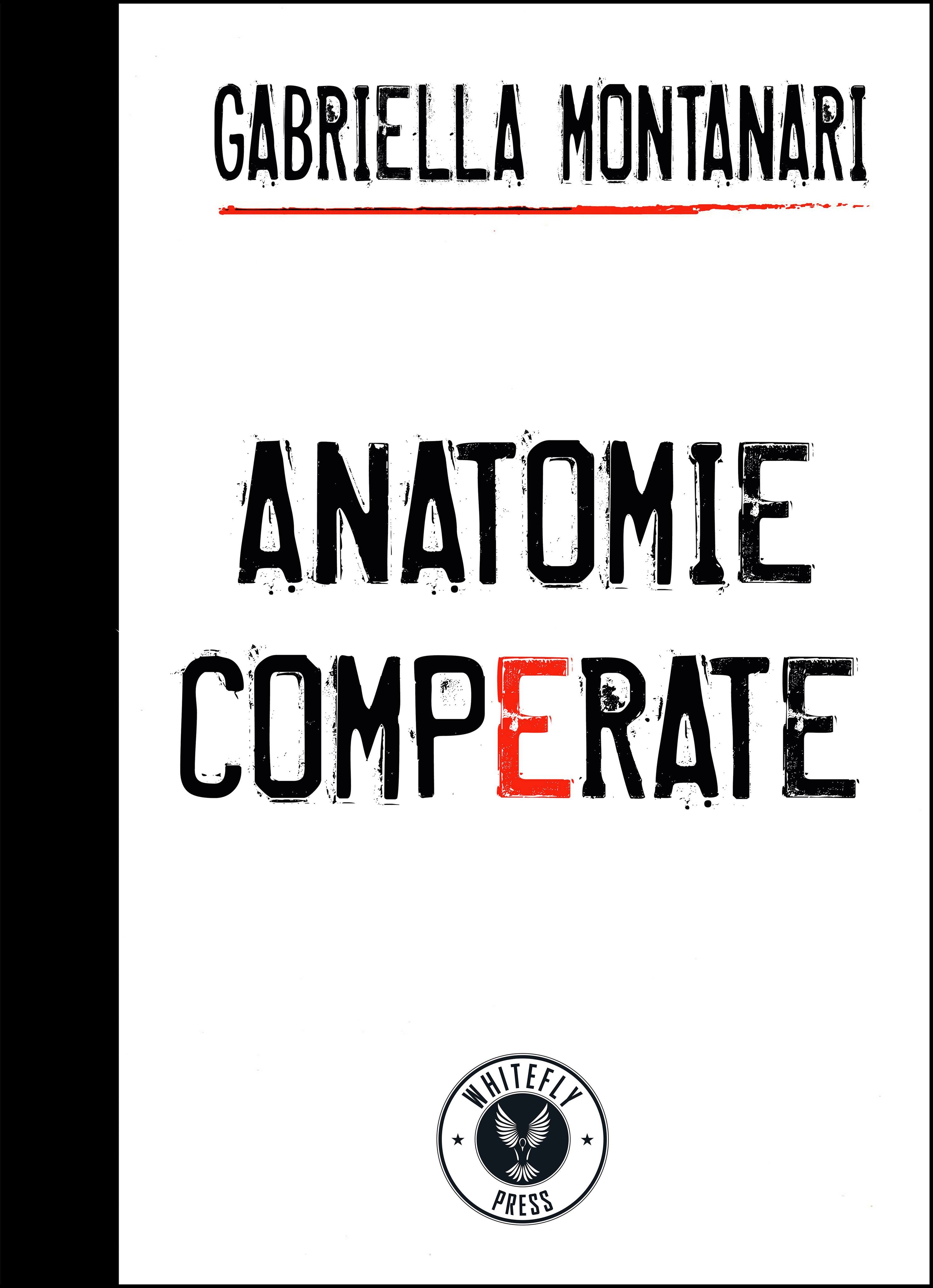Anatomie comperate[1] di Gabriella Montanari scompone il corpo in una stagione di tempo fertile. Attraverso la fecondità dell’essere, rende vivacità ai simboli, odora di nettare, polpa umbratile e orlo selvaggio che arriva fino alla lotta dell’anima. Il succo della realtà è turgido e vitale, come l’estate cromata e il tempo florido e racchiuso:
«Le anime dei mezzadri accatastano polpe / in vista dell’estate eterna. / I monatti della zolla bottinano dal germoglio alla bara / orchestrando il requiem dei piccioli. / Linfa, cesoiate. Cassette di bemolle. / Dopo la K626 di Mozart, solo pane e salame. / Allergica ai nettari emotivi / lascio spasimanti maturi impiccati ai rami. / Lungo i filari / in cima a trattori turgidi / le cosce delle stagionali svelano tagli di pesca. / Il succo cola, / macchia la canotta dei ricordi» (Luglio tra susine, brezze ed erpes zoster).
Cinzia Damassa, a tal proposito, scrive:
«Ogni poesia richiama un pezzo del corpo o una sua manifestazione; il corpo come una trappola, un espediente, un trampolino da cui lanciare l’anima, il corpo diapason delle nostre emozioni, dure da liberare, guarire, purificare. Il corpo come una mappa delle ferite, degli abbandoni, delle ingiustizie subite, il corpo vivisezionato per cercare una verità che abrade, che urla, che parla[2]».
La sua salmodia impudica è un altrove di sogno e sfacciata e vibrata profondità, che richiama ciò che Elio Grasso chiama fianco ecologico:
«È il fianco ecologico del libro, la sostanziale ricchezza dei vocaboli, altrove alquanto rara e inesperta. Nessun revival o letture da cocktail bar, ma turbolenti mini vortici in ogni pagina. Soltanto i competenti potranno sorridere, qui c’è tutto tranne che i trucchetti disadorni dell’attualità poetica. Manciate di witz salvaguardano da acquazzoni e da inviti ornamentali di torme dedite a perniciose stupidaggini poetiche. E dunque le parti del libro sono lobi resistenti e sbarre intralcianti i trovarobe. La copiosa schiera di attrezzi arcani e voluttuosi penetrano quanto basta perché si possa ancora dire che la poesia sia perfida e tormentosa, succulenta e rugosa, tirannica e titanica, ispirata, commemorativa o cosmologica: tanto non ce la farà mai a rinverdire i fasti di una vita, a essere vita almeno come minuscolo e didascalico replay».[3]
Dove il colore si screzia, si situa in angoli, si sacrifica alla terra, esso percepisce la fralezza di ogni luce di sogno e sacrificio. Così come la carnale potenza di ciò che si espone, si intuisce fatalmente, si destina nel contrario prenunziale, nelle cortecce-diaspore delle dimora o nel paradiso della vocalità («Solo gli occhi non sono invecchiati. / Gli stessi dell’ortolana di sei anni / con la bancarella davanti a casa. / Anche disillusa, persino felice / li riconoscerei da come affettano il mondo»):
«Nella mia terra strozziamo i preti / con lacci di acqua e farina, / sacrifichiamo rane ai festival democratici / mettiamo lucciole nei boccali / per fare luce ai sogni. / Siamo teste calde di sole / spaccato tra le onde e i castelli. / Di cosa odora la memoria? / Quanto misura una meta? / Alla guida dell’esistenza / assomigliamo a bambini interrotti, / la patente rosa peonia / le tasche piene di tappini / e gettoni per le giostre».
L’istante lirico non improvvisa irriverenze, si appropria della feritoia e della fessura, lontane così da ogni assuefazione e spogliate di ogni edulcorazione, per farsi
«[…] strabismo semantico che ravviva quella sorta di processione di idee che tuttavia non si accavallano, non si elidono a vicenda, ma vanno a comporre una nuova carta di significati di cui l’uomo non ha conoscenza e che bisogna recuperare se vogliamo intraprendere un nuovo percorso di speculazione emotiva. […] La posizione della poetessa è ferma e urticante e illumina quegli aspetti dell’esistenza che di solito restano nel buio della psiche a fermentare malanni irrisolvibili, a far vedere il mondo con le lenti di una miopia colpevolizzante. Lei invita a uscire dal pantano, dalla posizione supina in cui la società ha relegato soprattutto la donna e lo fa con libertà assoluta».[4]
La poesia di Gabriella Montanari non conosce relegazioni, si imbeve di sperdutezza smarrita e violenta, libera tagli e vento, schianti e segreti, ruvidi territori e generosità stratificata.
La parola non esce mai addolcita ma diviene dolce, si stratifica nella coscienza nelle metafore che lasciano lividi, negli incubi spezzati, nelle fiabe terribili, perché solo «le parole violate sopravvivono all’usura, / digitale è il segno, la cura».
Esiste una sorta di inviolabilità in questa gestuale ritualità poetica, anche quando diventa dura e scabra. Tale inviolabilità carnale resta intatta anche dopo il naufragio, la frattura domestica, il perdono ricostruito e la voce rammendata (e rammentata).
La carnalità è creaturalità e pena, che si ibrida, si imbastardisce con il fango e il dolore, la lontananza, i minuti contati, l’infanzia che sceneggia i mondi, il conato spoglio dell’essere come erba appena tagliata e monete matte:
«Penso agli uomini tuberi, alle donne cucurbitacee / ai bambini che non scuociono / e agli animali che non si piegano. / Non ci sono aggettivi ma stupori / e nemmeno lettere, solo numeri da circo. / Un giorno scriverò dell’orto umano / e dell’ecologia sociale. / Il giorno in cui la penna / non saprà che farsene del mio permesso. / Intanto Pinocchio scava, piange e scava / nella mia campagna spoglia di miracoli. / Ligabue pattuglia il Po / con uno specchio al collo / e troppe bestie in gola. / L’infanzia sceneggia mondi / di cui restano appesi agli alberi / monete matte e zoccoli».
Le resine e le arcate conoscono ritardi di padre, l’avorio braccato del sorriso materno, la merenda di neve e saba «per sfamare i dissapori di casa»:
«Un tempo bastava una merenda di neve e saba / per sfamare i dissapori di casa. / Ora gli inverni neanche immaginano / la timidezza del gelo. / Boreale è il tramonto / di un pretesto chiamato amore. / Suonano il rondò delle stagioni, / i fiocchi mi accarezzano e poi muoiono. / Il setto nasale occluso da una carota. / Ma neanche i passeri ridono, / Natale sarà un pupazzo di terza mano».
La carnale disposizione del gesto poetico, dunque, è tale perché sfronda la creaturalità nel dettaglio ombroso del tempo, il particolare sfrontato nelle simmetrie serali.
Se di fisiologia lirica, si tratta, è un tempio di carne, dove il corpo è ciò che raccoglie la realtà, la vive, la subisce nei fantasmi e nei ricordi sottili di ultime nevi, riporta fughe, anamnesi («Il sole spruzza speranze che nessuno vede»), odori, distanze comprate e ditali di sogno.
Dove tutto sembra indurirsi, farsi materia sofferta, unirsi allo sfioramento di ciò che sprofonda, la parola emerge, non solo intatta nella sua ferita, ma come se si congiungesse con la realtà più nuda e con l’idrogenesi del tempo. I testi toccano, pertanto, il dramma perduto che salva, le sillabe cacciate dal petto, il coraggio della parola che muta come glicine, la bestemmia sorgiva dell’espressione e la disabitata nostalgia di ogni torpore:
«Di un ventisei maggio consacrato e brindato / porto all’anulare un alone sinistro / memore dei carati di Cartier. / Ma ora io sono luglio, sto in un colosseo di fieno. / Gli umani sguazzano nell’arena di paglia / e lui, più giovane di venticinque chili, / mi sfiora la buccia del naso. / È nostalgico per il giocattolo perso. / Mentre la notte è un pedalare lento di luna / risorgo dalla schiuma del luppolo / come una venere / uccisa dalle perle».
Il suo meta-linguaggio[5] serve per sezionare il foglio, con cui la realtà, con le sue aggressioni, crudeltà ma anche con lo sperpero della gioia delle cose che sono, porge stelle avide di cosmo e palmi di mani, come recano queste voci sul limen di madre:
«Vi ho lasciato sole, voci. / Avevo smanie inconciliabili / con la vostra sete di latte. / mentre il temporale dilata il mare / i mitili offrono il nero allo scempio. / Le gabbianelle suonano a morto. / Ho un vago sentore di madre».
I ricordi degli spazi amanti e amati della solitudine della carne lirica, il sangue passato e presente, la divinità della materia perforata, l’esistenza sotto la pelle, la lingua innocente del risvolto di arsenico, il parto delle pupille raccolgono la gestazione dell’amore che odora di vita («Ma vi amo / per l’odore di vita / e di pane all’olio / con cui mi sfornate le albe»), lo stupore delle andate e dei ritorni conciliano la lingua del mondo («ricomincio da dove finiscono i viaggi»), il suo dono di abbondanza («Leggo nei tuoi polsi la nostra abbondanza. / Spargono grumi di melagrana là dove andremo. / Allora coglimi, prima dell’avvoltoio»), il suo filo eterno ed evaso come abbandono di buio:
«Nel tuo groviglio / di galeoni e astronavi / vige la legge onnipotente / dei tempi buoni, delle merende. / Sei angelico quando mi respingi. / Tu che sventri orsetti / per ritrovare il filo, il buco caldo. / Il tuo biondo che tira alla senape / la rabbia con cui mastichi il seno. / Sei morbido quando mi rinneghi. / Imperi sulle mie terre romano-galliche / come un sole di razza / a cui rivolgersi in silenzio. / Sei me quando ti smarrisci. / Io evado al buio, come le quaglie».
Queste cavità abitative, come si legge in un testo dolce e violento, dove «si divorzia da un amore, non dalle sue tinte», germinano nei sieri nuziali, nelle dita di sabbia spalancate, dove tra grida di moka e fiati, le iridi sono sfogliate e cercano radici introvabili.
L’amore di Gabriella Montanari è sperduto, sembra incelarsi nella terra più rastremata ed estrema, figurando un mondo di cacce chiuse, pasti svaporati, bilici abrasi e risvegli.
Dopo l’amore si rimane muti e molli, oltre il sole sfacciato, gli inverni oculari, i peripli delle nostre pose plastiche, appena incontrate dalle ossa sguainate contro il tempo.
In ciò che si rivela e si svela, Gabriella Montanari scompone ogni umanità privata, ma non per un gioco autoreferenziale smunto, bensì per portare il canto dell’inizio di ogni cosa, la durata di allure di ciò che si unisce.
Le chimiche e le vie lattee strappano ogni sorso finale e rubato, diventando lucenti come corpo che guarda:
«Non siamo forse gengive / che blaterano storie / di cui si è perso il sangue? / C’era una volta / e c’è una casa di carni / con tetti pazienti / e mattoni come non ne fanno più. / Mia prima e ultima dimora, / corpo che mi guardi, / covo di anatomie comperate coi risparmi. / Il divino è nelle tue meccaniche, / sacro è il rigore con cui profani l’anima. / In cambio di tremiti e disfunzioni / ti rendo questi versi perché sono le tue visioni. / Il tempo è il più caduco dei nostri organi. / Non sappiamo inneggiare al giorno».
[1] Montanari G., Anatomie comperate, Vague Edizioni, Torino 2018.
[2] Damassa C., cit., p.7.
[3] Grasso E., cit., p.9.
[4] Maffia D., cit., pp.10-11.
[5] Cfr. Demi C., L’arsenico poetico di Gabriella Montanari, (https://altritaliani.net/larsenico-poetico-di-gabriella-montanari/), 7 ottobre 2013.
Montanari G., Anatomie comperate, Vague Edizioni, Torino 2018, pp. 108, Euro 14.
Montanari G., Anatomie comperate, Vague Edizioni, Torino 2018.
Demi C., L’arsenico poetico di Gabriella Montanari, (https://altritaliani.net/larsenico-poetico-di-gabriella-montanari/), 7 ottobre 2013.