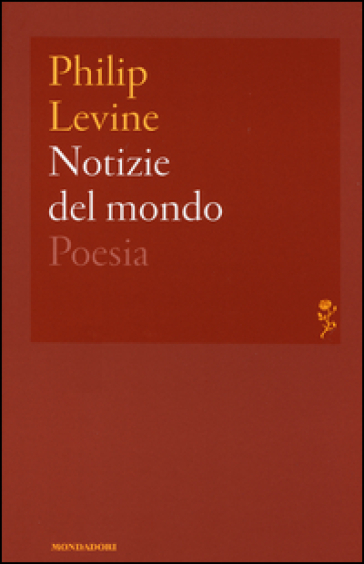L’ultimo libro di Philip Levine, Notizie del mondo (pubblicato negli Stati Uniti nel 2009), edito da Mondadori e tradotto da Giuseppe Strazzeri, condensa la policromia dei frammenti, impossessandosi, attraverso profonde ricognizioni e agnizioni, del continente perduto del tempo, e raccogliendo, infine, l’emersione della memoria nel frangimento assiso dell’esperienza.
Morto il 14 febbraio del 2015, nominato Poeta Laureato degli Stati Uniti nel 2011, Levine ha vissuto addosso la dinamica transeunte americana: nato a Detroit, dove ha lavorato nell’industria automobilistica fino a Brooklyn, l’Iowa, e infine, Fresno, in California, dove si è spento per un cancro al pancreas.
Ma quali notizie ci porta Levine? Cosa ridesta la sua attrattiva del mondo? Egli condensa la dura scorza dell’esperienza reale in una dinamica interiore quotidiana che emerge, prepotente, in una pervasione raccolta e in una passione gremita, estrema e marginale che «dichiarano», come sostiene Caterina Ricciardi, «un’ars poetica di spoglia laconicità, di una quasi rinuncia della parola a tradurre le realtà più ordinarie, le più semplici e terragne, e le più “morandiane”, se osservate nel mistero del loro legame con l’esistenza: dunque le più difficili da esprimere. È questa onestà di fondo nella scrittura poetica e nel commento alla vita a sostenere il ritratto di superficie di Levine nel panorama della poesia americana del Novecento»: «Certe cose le sai da tutta la vita. Sono così semplici e vere che devono essere dette senza eleganza, metro o rima, / devono esser messe sul tavolo accanto alla saliera, / al bicchiere dell’acqua, / all’assenza di luce che si addensa / nelle ombre delle cornici dei quadri, devono essere nude e sole, devono stare per se stesse».
Il racconto del mondo vissuto non accoglie la prosperità remota della traccia memoriale, ma nella oscura necessità della narrazione si spinge all’esistenza senza filtri, come processione di eventi, che nella loro heideggeriana «gettatezza», respirano e si dilatano come assedio di congedo e commiato ultimo, come sostenuto da David Barber sul “Boston Globe“, avendo: «Tutte le caratteristiche di un testamento di commiato, con le sue ruminazioni autunnali sulla storia personale e sulle sue rimembranze infestate di cose passate, ma Levine è un artigiano troppo scaltro per accontentarsi di chiamate alla ribalta doverose, e un ironista troppo ostinato per cadere preda di falsa nostalgia. Se certe ossessioni qui sono destinate a colpire i lettori di lunga data come vecchie notizie (innocenza ed esperienza, il lavoro manuale e la lotta di classe), la lingua viscerale che arricchisce le poesie avverte ancora calore di stampa».
La sapienza delle immagini, inserite in una narrazione potente ed estrema, accoglie un interstizio tra l’io e il materiale vissuto che diventa parte del tempo e del mondo («Tutte queste voci stanno cantando su chi sei tu. Per un momento sei parte della terraferma» Isole), promana la sua ricchezza esperienziale e dettaglia, in tutte le stratificazioni poetiche, una dizione immaginativa e una profondità che lasciano respirare le pagine.
Afferma Giuseppe Grattacaso: «Il verso di forte respiro narrativo che caratterizza queste poesie non cerca di ricostruire il passato attribuendogli solennità, né è orientato ad offrire un affresco realistico di una società marginale e depressa. Il viaggio nella memoria, che è anche ricostruzione di una geografia privata che spazia da Detroit a Cuba, dal Baltico delle memorie familiari al Portogallo, procede a sbalzi, con improvvise ellissi e con scarti inattesi, che rendono frammentaria e parziale la ricostruzione dei singoli avvenimenti. Delle vite delle persone che con il poeta hanno condiviso un pezzo di esistenza, o di quelle appena conosciute, è impossibile ricostruire le ragioni che hanno portato a scelte spesso insensate o sapere dove le ha condotte in seguito il destino. Anzi i segmenti che riaffiorano dimostrano come la realtà si sistemi in una composizione traballante e dissennata. Dal movimento a ritroso nel tempo nasce una sorta di commovente Spoon River, un cimitero dove non ci sono defunti a ricordare la propria esistenza passata, ma uomini colti in un attimo lieve e indeterminato della propria vita presente, lasciati come sospesi a chiedersi e a chiederci il senso delle azioni compiute e più in generale della loro e della nostra presenza nel mondo».
La trasformazione del passato condensa e cancella, ravviva e restituisce l’imprecisa sagoma delle figure in una precisa processione di stupor e grazia quasi veterotestamentaria, come accade in Ritorno a casa: «Un vero posto nella vera città / dove tutti siamo cresciuti. Ci passiamo accanto tu ed io / sulla strada di scuola o tornando a casa / dopo il lavoro. È dove sorgeva la vecchia casa / un tempo, i grandi occhi spalancati notte e giorno, / rimpiazzata dal nulla. Potresti definirlo un lotto vacante / ma vuoto non è. Iris selvatici in aprile, / come una spuma di bianchi fiori di pizzo che Mamma chiamava / cicoria selvatica, e ancora euforbia, segale, ginestra, / in autunno la seconda fioritura del rabarbaro / che nessuno raccoglie, una lunga trincea / adatta alla guerra e un tempo disseminata / delle travi rimaste dalla prima casa / crollata proprio qui». Poi emerge l’annuncio di una agnizione femminile: «Nella casa / che una volta qui sorgeva, si è levata un’ombra / per dare spazio al giorno, un ricordo di donna / quasi prende forma mentre lei resta / pietrificata alla finestra. Se stiamo zitti / potremmo forse udire qualcosa di vivo / muoversi lungo i vicoli polverosi / o nei giardinetti abbandonati, qualche / cosa lasciata alle spalle, lo spirito del luogo / che ci dà il benvenuto, se il luogo uno spirito l’avesse»
È interessato ai processi del mondo, ai dispiegamenti e alle disfunzioni irreversibili dell’umano, in cui l’abisso, la violenza, la povertà, la tessitura del desiderio, il disastro, rappresentano la storia dell’essenza americana e di tutti i suoi ossimori, come narra in Chiuso (Closed): «La trattoria era chiusa. I due fratelli osservavano dalla finestra & non riuscivano a scorgere nessuno dietro al bancone. Una lucina era accesa sulla cassa […] Max, il fratello più piantato con un giaccone a scacchi, suggerì di trovare un altro posto. «Se Teresa non è aperto niente è aperto» disse Bernie, il fratello più alto, allampanato. «C’era il greco» disse Max «dài, è qui vicino». Il greco in realtà era Yervan, un armeno che aveva aperto una piccola gastronomia dall’altra parte dell’impianto di trasmissione. Bernie pensò di accendersi una canna nel breve tragitto ma si rese conto che era troppo stanco anche per quello. «Oggi cos’hai, Nick?» disse Max.«Che cosa vuoi?» disse il greco «Caffè & due uova al tegamino con pancetta & toast integrale» disse Bernie. Yervan gli disse di provare da Teresa, che quello non era un ristorante. «E tu chiami Teresa un ristorante?» disse Max «È da otto anni che non penso ad altro che alla colazione» disse Bernie «Questo mi ha rovinato l’intero fine settimana anzi la vita intera». A quel punto il sole aveva schiarito le ciminiere dell’impianto di trasmissione & attraversato le finestre polverose dell’alimentari. Il greco si schermò gli occhi & capì che sarebbe stata una lunga giornata […] «Io ho caffè e latte fresco» disse «& quelle tortine che vi piacciono» «E va bene» disse Bernie & posò entrambe le mani sul bancone, abbandonandosi con tutto il suo peso «Avessi anche solo un grammo di energia», disse, «piangerei».
Scrive Maurizio Cucchi: «Levine raccoglie brandelli di vicende o circostanze lontane, come nel ricordo del fratello di ritorno dalla guerra. Appaiono in queste Notizie luoghi di un’immensa geografia, dalle terre baltiche, da cui veniva la famiglia del poeta, all’Australia, al Portogallo e alla Spagna, in un susseguirsi di componimenti di ampio respiro, e felicemente gremiti di concretezza, ma anche di testi di prosa poetica, micro racconti intensi e limpidi, dove continua ad agire una capacità sempre viva di sorprendersi davanti al mondo».
Come ha giustamente affermato Alfred Knopf, rapportando la poesia di Levine a quella di Carl Sandburg che ha toccato le durezze emarginate del Mid-West, questa incandescente e religiosa (ma non confessionale) materia poetica contiene una «incalzante risacca di perdita e sconfitta». È la sconfitta del singolo che trova chiuso dappertutto, trovando solo cibo freddo. È la chiusura della storia al sogno di un’intera classe, espressa nei dialoghi liminali: «Ci spogliammo nella prima sera tiepida di primavera / e ci gettammo correndo nel Detroit River / per battezzarci nella salamoia / di ricambi d’auto, pesci morti, biciclette rubate, / neve sciolta. Ricordo che mi immersi / mano nella mano con una ginnasiale polacca / che non avevo mai visto, e ricordo come gridammo / insieme quando il freddo ci tolse / il fiato, e che risalii attraverso strati / di oscurità nell’atmosfera ultima e senza luna / che era il mondo, che lei tornò in superficie / dopo di me e nuotammo al largo / sulle acque senza stelle verso le luci / di Jefferson Avenue e le ciminiere / rigide e fisse della vecchia fabbrica di stufe. / Alla fine ci rigirammo e non c’era più isola, / ma una perfetta silenziosa oscurità fino a dove / arrivava la vista, e poi una luce / e un’altra oscillanti basse davanti a noi / per ricondurci a casa, forse mercantili o fumatori / che passavano solitari. Ritornammo con l’affanno / alla spiaggia aspra e grigia su cui evitammo / di coricarci, le pile umide dei nostri vestiti, / e ci vestimmo fianco a fianco in silenzio / per tornare donde eravamo venuti».
Commenta Paolo Febbraro: «Il bagno nel fiume cittadino con una ragazza ancora estranea, l’andare lontano, perdersi, trovare gli indizi del ritorno, chiudere l’episodio nella notte: qualcosa di naturale è accaduto, una comunione con l’acqua, la città, il corpo femminile, il silenzio. dai ricambi d’auto, pesci morti e biciclette che ingombrano l’ingresso della poesia, passiamo all’«atmosfera ultima e senza luna», alla «perfetta oscurità» di un immergersi che è conoscenza e accettazione. […] i due giovani sentono crescere il riserbo e la timidezza di una trasformazione subita, di una fusione assoluta e insieme momentanea, occhiutamente recintata dalle luci del traffico e dell’età adulta».
Radunare le notizie del mondo significa obbedire alla realtà, mettersi in ascolto della sua incipienza segreta, dove la narrazione mette a fuoco la sua essenziale epifania compressa, catturando la rappresa aegritudo di un tempo primario («Ho dovuto mettere un piede avanti all’altro, / tenermi in equilibrio con le braccia tese, guardare avanti, / tirare il fiato come un principiante, e confidare nell’arrivo»), nella contusa lotta del nome che attraversa il ricordo del nonno nell’oceano («Pensaci, / il mio nome non più una porzione / di me, non più gonfio / o ammaccato, non più a sobbollire / in un denso compostaggio di memoria / o in quello più semplice di ossa, sabbia / per gatti, le radici di un eucalipto / che io piantai nel ’73, / ma un minuscolo me che nulla prenda e nulla / dia, vuoto, e libero finalmente»). Oppure come l’obliqua e sterrata Suite di Dearborn, dove il mondo immaginale domestico di un dipendente decrepito e insonne della Ford si dispone in una lingua provata e privata, mentre «si alza / dal letto e gira per la sua magione / in vestaglia e ciabatte, chiedendosi / se questo è proprio tutto ciò / che occorre per diventare Henry Ford, / l’uomo che ha creato / il mondo moderno. I cieli / sopra la grande fabbrica sul Rouge / sono neri di fuliggine, senza stelle, / il mondo intero è senza stelle adesso, tutto / perché è stato lui a renderlo / a sua immagine, gratificazione non da poco».
Il mondo di Levine ha la dignità lucente del lavoro, il respiro senza fine della meraviglia sofferta che trasmigra e si ricompone, lasciando poi anche le sue ferite, il suo tenero fallimento, l’ombra dell’irrealizzazione, ma non si definisce mai nella riduzione e nell’annichilimento, bensì riprende la sua sopravanzata attrattiva, come accade in Dell’amore e altri disastri, dove «l’operatore di presse del Nord / incontrò l’assemblatrice del West Virginia / in un bar vicino allo stadio». La donna, in un linguaggio pervasivo e minimo, parla delle sue mani e dei solchi profondi scavati dal lavoro che le segnano: «La linea della vita» / disse lui «qual è?» «Nessuna» / rispose lei e lui notò che aveva occhi / nocciola disseminati di pagliuzze / d’oro, e poi – imbarazzato – tornò / a guardarle la mano», che era snella e affusolata, nonostante fosse ingiallita dai calli. Poi, prendendo un tovagliolo dal bancone, gli strofina gli occhiali per pulire qualcosa dallo zigomo sinistro. Egli non riesce a vedere nulla di diverso o «forse credere alla cieca». «E pensò «Meglio / filarsela prima che sia troppo tardi», ma / sospettò che troppo tardi era ciò che desiderava».
PHILIP LEVINE, Notizie del mondo, Mondadori, Milano 2015, euro 18.