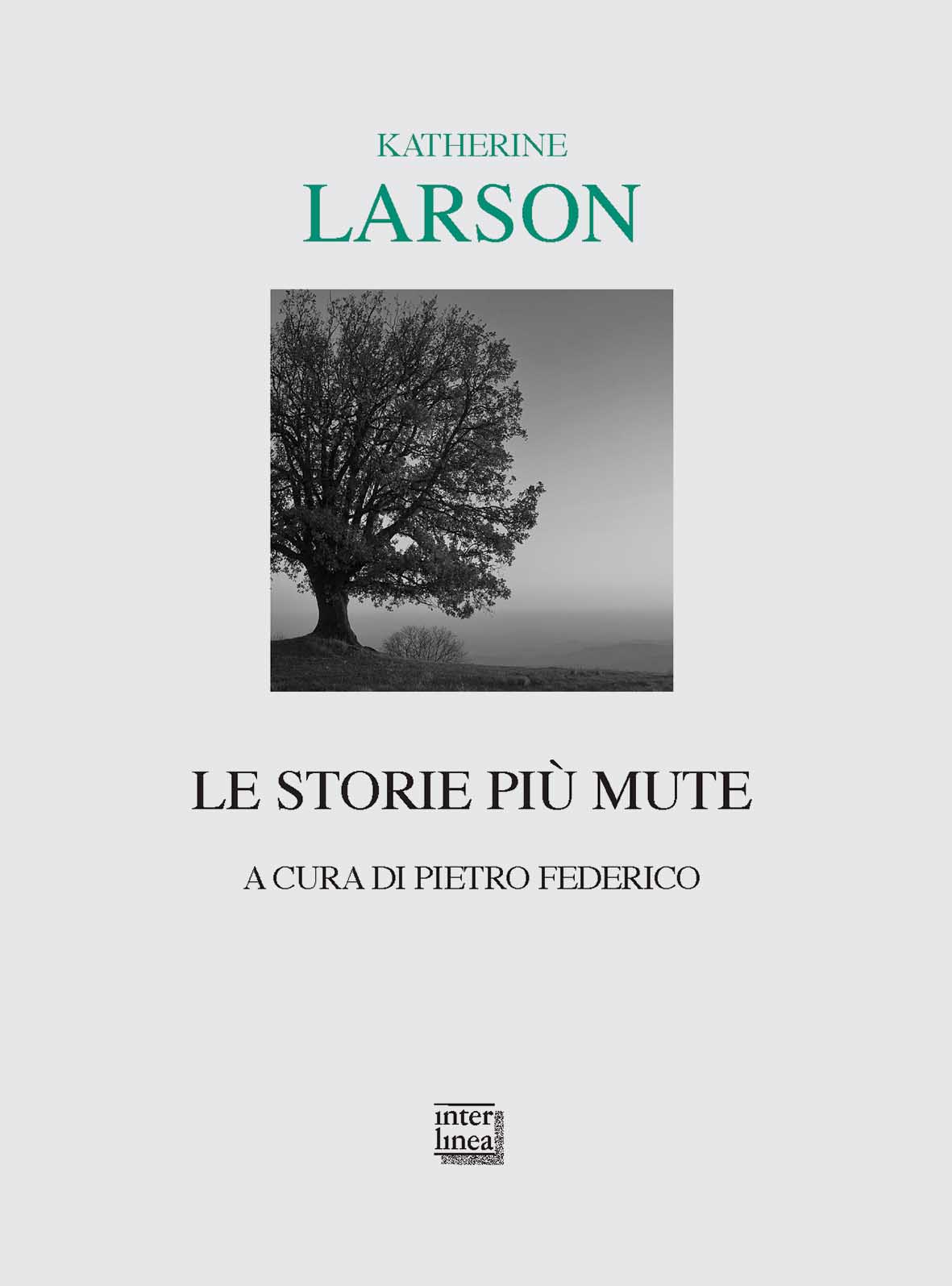La poesia di Katherine Larson (1977) racchiude una visitazione e una fusione, non solo per l’irradiata e dolcissima tensione dell’io che ne anima la stanza interiore, ma anche per il riconoscimento di una vocazione che non ha confini, bensì li solca, li abita e ne è abitata.
Biologa molecolare a Tucson, Arizona, di recente, ha ricevuto il premio del Festival internazionale di poesia civile di Vercelli e nel 2010 è stata consacrata con la Yale Series of Younger Poets Competition dell’Università di Yale e pubblicata successivamente dalla Yale University Press, vincendo poi il Kate Tufts Discovery Award, successivamente il Levis Reading Prize from Virginia Commonwealth University e il Gold Medal Prize in the Poetry Category del “ForeWord Magazine”.
La pubblicazione del testo Le storie più mute, edito dalla prestigiosa Interlinea di Novara, con la cura di Pietro Federico e con una nota di Bryan Giemza, per la prima volta tradotta in italiano, incardina una fonte preziosa che custodisce una generatività lessicale e una domanda di senso che rapisce e offre segni senza distanze, attraverso l’aggirata nudità dell’essere e della visione, che si chiariscono in tutta la loro apicale trasparenza di prodigio e sintesi, mistero e forma.
A proposito della visione trasmessa del mondo, Pietro Federico, nella prefazione, così scrive:
«[…] la Larson da questa visione si sente guardata. Stiamo parlando di un modo di concepire l’esistenza che insorge dalla consapevolezza di essere stati prima di tutto misteriosamente visti, e di esserlo stati insieme al più piccolo filo d’erba e al moto migratorio delle nuvole. Una concezione che, volessimo osare darle un nome, non potrebbe dirsi che medievale. […] Per la Larson la poesia non è una forma di espressione, ma prima e innanzi tutto una forma di conoscenza. Così come lo è la genetica pediatrica ed ecologica, l’astrobiologia, l’astronomia, la farmacologia, la geologia, tutti campi in cui la Larson ha lavorato con passione, rivelando nella sua persona la possibilità e la bellezza di un approccio unito e integrale alla conoscenza. Si scrive poesia, si legge poesia per conoscere sé e il mondo. Poesia è innanzitutto, ascolto, apertura, un fare spazio. Non è un dire o un proiettare se stessi al di fuori» (p.5).
Unendo e sciogliendo due universi, solo in apparenza lontani, la scienza e la poesia, Katherine Larson predispone la materia vivente alla forma della sua vocazione. È un laboratorio di trasparenza che si enuncia in tutta la sua forza vitale, che riguarda il limite e lo stupore, la figuralità e la creaturalità, il simbolo e lo scavo acceso.
Se la sua matrice formativa tocca Marianne Moore, Elizabeth Bishop, spingendosi fino a Neruda e Tranströmer, la sua poesia risale con acume verso la realtà che chiama e richiama, mediante lo sguardo che non si dilegua, ma che si spinge verso una sostanzialità profonda e vertiginosa.
La veggenza rivelativa è una chiarità «di qualcosa da lasciare entrare nello sguardo» (Pietro Federico, p.6) che è la prova di una tensione epistemologica e di uno stupore che appare e si dispiega, disvelando il reale, in tutta la sua ostentata e misteriosa bellezza fondante.
In un’intervista rilasciata ad Alessandro Zaccuri su “Avvenire”, la poetessa, a proposito del sentimento della meraviglia, così afferma:
«[…] Uno dei miei modelli è da sempre Jules Supervielle, che riusciva a racchiudere concetti di estrema complessità in versi dall’apparenza semplicissima. In quanto forma di conoscenza, la poesia si basa sull’esperienza e sulla condivisione di questa stessa esperienza con gli altri. […] Penso spesso alle intuizioni di Gaston Bachelard, che già un secolo fa aveva insistito sull’interconnessione fra l’immensità dell’universo e le scoperte che si stavano susseguendo nel campo dell’infinitamente piccolo. Macrocosmo e microcosmo sono concetti più attuali che mai, e sempre più convergenti. Dall’astrofisica alle neuroscienze, le occasioni di meraviglia derivanti dalla ricerca si stanno moltiplicando. Ogni volta che il confine delle nostre conoscenze, o della nostra ignoranza, si sposta un po’ più in là, la prima reazione è di stupore. E di riconoscenza».
La densità stuporosa di Katherine Larson è impastata con lo sguardo. In esso trova la verificabile constatazione strutturale di un rapporto inesausto, il riconoscimento del mistero visibile e toccabile, la percezione infinita, in cui la metafora tinge l’accadere del mondo senza estenuarsi ma con una sottile e sorvegliata scrittura, che rovescia clessidre e prodigi, raccontando l’ardore e l’oblio, la vita e l’arsura come limite di pienezza. Le storie più mute ardono nelle più alte città della mente:
«Il canto che proviene dalla scuola / per bambini non vedenti / e la calma vastità del Mediterraneo sono metafore / per tutta quella solitudine resa / abbracciata dal tempo. / Il museo sul fianco del colle / con file di vascelli» arenati ne è pieno. / Un’immobilità così colma / come uno sposo amato da secoli. / Una pienezza colta solo in parte. / come clessidre / e meridiane che permettono al tempo di essere tradotto in elementi: sabbia, ombre. / E la risata / dei bagnanti dalla spiaggetta. / Il treno ferma appena fuori Napoli / dove compro un bicchiere / di spremuta fresca di mandarino / ed entro a Pompei. Non avrei potuto / immaginare questa grandezza. / Pilastri lampeggiano contro il cielo. / Templi dove il sole / scorre bianco / e sembra irradiare dall’interno / delle pietre / Certe storie / chiedono dimenticanza. / Altre, ti chiedono di credere con tutto te stesso. Ma penso / che altre ancora ci vivano. In più alte città / della mente / anche quelle più mute ardono» (Clessidre).
La chiamata della datità delle cose e dell’essere si dispiega nell’esistenza, nella metamorfosi e nella trasformazione, nella relazione, nella comunione che è sia delimitazione (cum – moenia) e sia soprattutto dono condiviso (cum – munus), frammento che brilla e si incide come un inizio di destini e destino. La luce colta e colata a guardia di un risveglio luminoso e di una essenziale nudità, come in Acquedotti:
«Le anguille trasparenti stanno migrando, scivolano / lungo le pietre immerse nel letto del fiume, argento / vivo dentro argento vivo finchè il fiume non è altro che una treccia / senza riposo di luce colata. / Sembra così semplice. L’architettura che cede / lasciando spazio a ciò che non può trattenere. / Ricordi quando sentivamo tutto ciò? / Come dormivamo tra le rovine / della notte come acqua calma, antica. E ci svegliavamo / luminosi. Nudi come betulle».
La scena composta è un dettaglio che trema nei suoi emblemi e nell’abbondanza dei paesaggi, ma non perché sia diluito e criptato bensì perché il mondo nasce con segreta armonia ogni giorno e l’autrice ne registra i battiti:
«Oh, mia terra, amore / di trilobiti e fiori di loto tremanti, / e di tartarughe in stagni neri / e di barche fatte coi quotidiani / da bambini mai baciati nel modo spagliato. / Il buio mi lascia solo questa cena: un tulipano / lacerato, un frammento di rabarbaro che brilla. / Perché certe piante indossano un volto umano? / Cosa fa tremare una stella / nel suo manto di fiamma? / Amore, qui la pioggia / macchia le meridiane per tutta la notte. Docet umbra / è inciso su una. Su un’altra Incipit» (Paesaggio che inclina verso l’oblio).
La piccolezza è la finitudine di una misura di pace immersa nell’infinito, mentre si alternano amore e morte in ogni indissolubilità («Parliamo di cose piccole. / Di come la moschea e la mezza luna / siano sentinelle / contro il cielo sanguinante. Di come sia vicina / la stagione del mango. / Gli dico che so perché / la gente fa l’amore quando / torna dai funerali. E perché l’attrazione / del corpo fa eco alle maree / e a occhi ampi come tombe. / Di come la passiflora slanci i suoi stami / sfidando il proprio gambo»), dove nessuna parola può nascondere lo strappo della rondine, levata dal prato.
O ancora dove nella sera di bassa marea, l’incontro con il proprio fondo ha occhi chiusi, il mondo bracca e si scioglie, e si apre tremando nelle moltitudini e nelle ore disumane di bellezza e violenza:
«[…] Lei pensa alla cena con quell’uomo. / Segatura per terra. Una cozza aperta e rugginosa / contro l’ebano lucido della zuppiera, / il suo mare ha l’odore della spiaggia quando il mare si ritira, / mentre cammini in un’ora disumana / quando il mondo si scioglie nell’azzurro / di un’unica vetrata colorata, e le ombre e i gabbiani / si fondono in un’unica cosa: nella fame. / E d’improvviso si accorge di volere quell’uomo / all’altro capo della tavola, seduta lì accanto sul bus. / Ma la fa tremare il modo / in cui i gusci si spaccano – come due metà nere / di luna che non mandano luce, / solo ombre. Moltitudini» (Sera di bassa marea).
Il processo delle immagini purificate è l’esito di una rivelazione. Tutto afferma un oltre e tutto si rivela: carità e chiarità insieme e fuse, ancora una volta. È l’aspetto convesso del vivente che accompagna le oscillazioni statuarie delle gru tra il cielo e il verme famelico, quando si slacciano i voli, come accade in Statuario, dove la memoria trascende nel sublime e «da qualche parte / tra la gru e il verme / tra i giorni che passano / e i giorni che mi passano attraverso / c’è la mente. Il ricordo / che trascende il corpo, / e il dolore che lo inchioda».
In Mimesi e Mimica, Katherine Larson scioglie i nodi di due mondi mai antitetici. Il riconoscimento del mistero dell’essere, la sua numinosa confluenza radiosa che vibra in una comunione, appunto, è sia splendore e sia creaturalità dispiegata. È il palcoscenico dell’esistere a divenire oggetto di poesia e pensiero, ed è il suo varco misterioso a farsi segnale, comprensione dell’umano e trasparente coincidenza di opposti: «Una volta credevo che la scienza si occupasse / solo di certezza. Più tardi ne ho riconosciuto il mistero. / Non esiste un linguaggio per questo, – / per il modo in cui ti vedo quando splendi. / Le nostre radici sono mimesi, le nostre ali mimica».
Non c’è fine nella numinosa epifania che la scena trasmette. L’io si trova dinanzi a una indocile coltre di stupore e bellezza. È una profondità che coglie i dettagli e le orme della realtà come fertile creazione e vertigine di una presenza desiderata. Ecco Fine estate:
«Le cavallette saltano nel crepuscolo / mentre il sole è un fiasco fiammeggiante di scotch. / Mi piacciono quando sono così, ubriaconi felici / che si lanciano verso / la tenue zanna della luna / come volani / in un versione divina di badminton / dove nessuno slancio verso l’assoluto / ha una fine. / Agosto, ogni filo d’erba / indossa la corona d’oro in cui morirà. / È la stessa dignità / che muove il vento affinchè asciughi prima il bucato, / non è meraviglioso: i lenzuoli / sfiorano l’aria in un balletto / per il quale solo il cielo può essere il palcoscenico».
Nella poesia di Katherine Larson, l’ombra, che accosta la luce, potenzia la visione in un accenno di unità e metamorfosi, come scrive Pietro Federico: «In questo senso io e universo (il quale è ben più che un immenso insieme di cose, ma il suo movimento, la sua tensione interna) si ritrovano spesso in una dimensione tale di comunione da risultare spesso in metamorfosi» (p.8).
I bagliori hanno l’oro alto dell’avena di mare ma anche la notte e il gelo della pioggia, fino a cogliere un tremore «come uno spirito / alla deriva nell’erba lacera». La luminosità non si appropria di detriti ma sa incendiare il tempo rimasto come il vino bevuto e avanzato, poiché la creazione afferma la sua consegna e la sua vocazione offerta all’ultimo corpo a corpo col mondo:
«L’oro alto dell’avena di mare tutto intorno, / i nostri occhi sono uccelli del paradiso. Il sole / viene a galla come il cadavere di un pesce rosso. / Il lungo fronte delle palafitte estive ora disabitate barcolla / tra le onde su gambe smangiate dal sale, / legno avvizzito come i volti di antichi sovrani. Addosso la notte e il gelo della pioggia. […] Poi i nostri occhi colgono un tremore, / come uno spirito / alla deriva nell’erba lacera. Decidiamo / di restare e di fargli un tempio / di anemoni rosa. Beviamo il vino avanzato. / Restiamo lì in piedi, corpo a corpo col mondo, / come arbusti nel giardino del re dopo la potatura» (Barboni sulla spiaggia sotto la X di un aereo).
L’analisi del reale chiede non solo la specifica attenzione contemplativa, sia come orante tensione epistemologica sia come “luogo” in cui il destino si porge, ma anche un rapporto di amore e di sofferenza, dove la relazione con l’altro rappresenta una abbandonata sperdutezza, come quando ci sono «notti in cui l’amarezza / del mondo dissolve come una mano fatta di fumo».
L’espansione immaginifica di Katherine Larson, allora, si compone di trasformazioni, di concepimenti, di barlumi rannicchiati e consegnati. Il suo mondo è ordinato e vissuto e, allo stesso tempo, vive di ciò che man mano si mescola, si concede e si appropria.
Il poiein ha vita quando riempie la sua accresciuta lotta interiore del movimento vitale, quando percepisce il dramma e la controversia profonda di una afflizione iridescente nel prisma delle immagini, come «Prismi silenziosi prima che il sole li colpisca»: «Draghiamo il ruscello con dei passini / e separiamo le libellule dalle damigelle - / i loro occhi come bulbi di inchiostro, mandibole che scattano / al contatto con al luce come se il mondo fosse pieno / di trappole minuscole, il loro delicato meccanismo / si è inceppato per trasformarsi. Gli appetiti / rimbalzano indietro con tale insistenza, vita, vita, vita contro / l’oscurità dei canneti».
La sua screziata ricerca è il suo inseguimento splendente di passeggeri bagliori di fiamma e parabole di luce, attraversa poi la vicinanza cartografa delle cose, quando la creaturale esplorazione marina e il desiderio stellato toccano non lo spazio delle discipline ma la loro iterazione che insegue le cavità dell’umano («Quanto siamo giovani di fronte alla storia della terra»), la sua conoscenza e co-nascenza di lingua fatta di ambra («Studi di un paesaggio in ceruleo e bagnasciuga, / case sul mare scheggiate / come grappoli di crostacei sbiancati dal sole / e abbarbicati alla scogliera, il piumaggio di cenere / dei pellicani che si levano in volo, si astraggono…») e la rappresentazione del mondo («Come capisco l’invenzione / dalla separazione? / Guardando dal balcone al crepuscolo / i delfini con quel muso schiacciato / volteggiare a onde come mucchi di foglie di eucalipto»).
La malattia mette a nudo le verità dell’anima, la poesia ricerca, braccando, il denso segreto che recupera la hopkinsiana freschezza sorgiva e antica in fondo alle cose («Vivevo là dove non c’è dissonanza / tra la mente e il corpo che la tiene, / in questo paradiso di tribolazioni devo credere / che le maree hanno un’unica semplice intenzione. / Un antico inno – mondo senza fine»), come ha suggerito Bryan Giemza nella sua Nota.
Il dramma umano è di fronte a una mendicante opzione che la poetessa ci illustra e ci fa guardare attraverso il legame indocile di particolare e universale della sua simmetria radiale, istante e senso del tempo della materia vivente, e tutte le cose si frammentano in qualcosa di essenziale e di eternità rintracciata e accogliente per «gustare la grazia terribile e commovente dell’essere» (Pietro Federico, p.10):
«Le melagrane sono sbavature di rossetto / nel riflesso appannato del cielo. / La città tremola nel calore. La mia gatta / raduna negli occhi un oro ogni giorno sempre più consapevole. / Premiamo il nostro corpo che annerisce contro un cielo così luminoso. / Tengo la gatta tra le braccia nella vetrata che svanisce. / Non fissiamo lo sguardo su niente in particolare, / un viale su cui i tuoi occhi fulvi si appoggiano così lontani / da inumidirsi. Nel mio laboratorio le cellule immortali / di un tumore si dividono e dividono. Le melagrane / sono quasi mature. Qualcuna è andata in pezzi / così come tutte le cose si frammentano in qualcosa di essenziale. / Niente è sublime o lo è ogni cosa» (Solarium).
Larson K., Le storie più mute, a cura di Pietro Federico, Interlinea, Novara 2016, pp. 128, Euro 12.